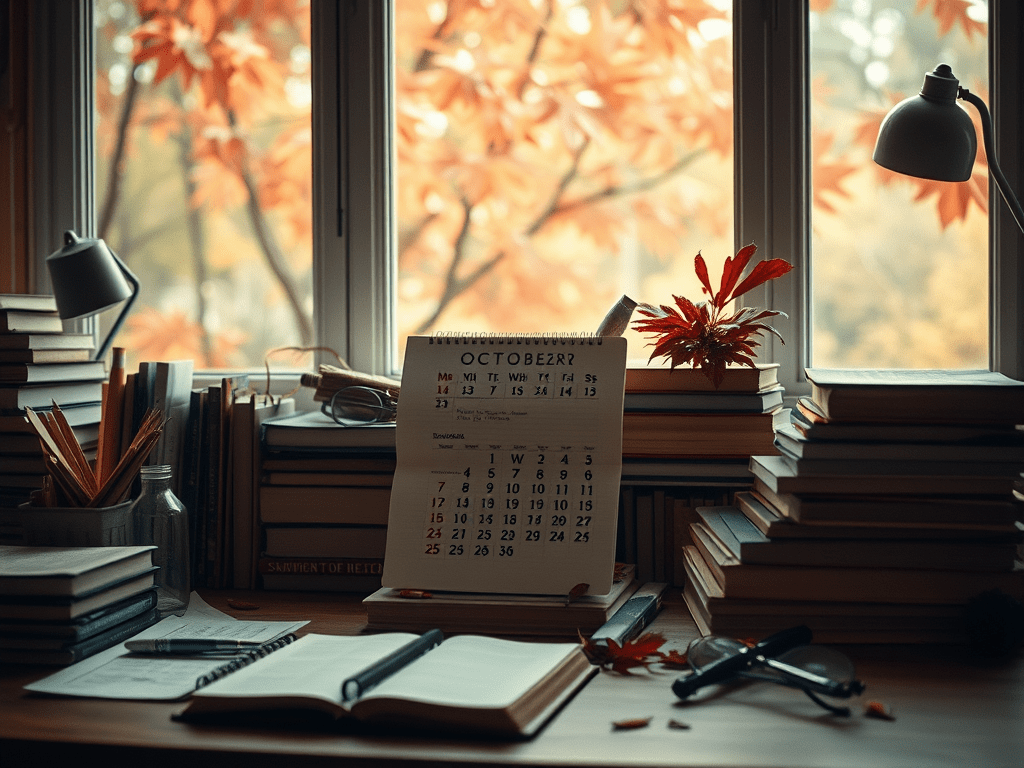Questi pensieri sono come foglie nel vento autunnale, caduti qua e là nel mese di ottobre su Facebook, dove sono rimasti finché qualcuno non ci è inciampato sopra. Un po’ come un romanzo di seconda mano su una bancarella: chi lo apre, per caso o per noia, magari trova proprio quel che cercava… oppure niente affatto, ma tant’è.
3 ottobre
Una mattina come tante, un vento umido spinge contro le finestre della classe gli ultimi spruzzi dell’uragano Helene che sta risalendo lungo tutta la costa est. Gli studenti cercano di farsi piacere la coniugazione dei verbi passivi che ho appena finito di spiegare e cominciano a scribacchiare sui fogli alcune frasi al passivo…
Qualcuno vuole condividere una frase?
Seth alza la mano: canes et feles ab advenis devorantur.
Sono talmente preso dalla lezione che comincio a tradurla ad alta voce… “Dogs and cats are eaten by foreign…” quando mi accorgo di cosa sto dicendo è ormai troppo tardi. Tutti stanno ridendo con i lucciconi agli occhi…
Guardo Seth con lo sguardo più incazzato che riesco a sfoggiare, ma il risultato è deludente perché sembro Muttley de La corsa più pazza del mondo, il cane di Dick Dastardly, con il mio broncio che scatena ancora più risate.
Seth fa spallucce, imperturbabile, e con la più strafottente faccia da schiaffi mi sferra la stoccata finale: “Prof, ma mi avevano detto che per questa lezione non c’era il fact check.”
Lo fisso per un altro secondo, incredulo. “Ora mi sta anche prendendo per il… gluteus maximus…”
La politica americana è esondata perfino nelle versioni di latino. Mi vedo già, tra qualche anno, a spiegare la grammatica delle fake nuntia.
Questo caos politico che si respira negli ultimi mesi mi ricorda i tempi del senato romano, quando Silla e Mario si davano battaglia per il potere, con riforme che duravano il tempo di un tweet.
E mentre vedo il Thanksgiving allontanarsi con le Kalende greche, mi preparo mentalmente a questa ‘bella’ pettinata elettorale.
8 ottobre
Sarà stato questo martedì di inizio autunno, o magari il primo odore del fumo dei camini accesi, fatto sta che oggi ho tentato di portare un po’ di filosofia in classe.
“Ragazzi, ogni giorno quando vengo a scuola, vedo delle scarpe appese al palo della luce tra Providence Rd e White Oak Avenue. E ogni volta, mi fermo a pensare. Pensateci anche voi: quelle scarpe sembrano sospese tra la vita e la morte, tra il passato e l’incertezza del futuro. Forse un segno, forse un memento mori che ci ricorda quanto fragile è la nostra esistenza, proprio come ci insegnano i poeti antichi. Mi viene in mente Seneca: la vita è breve, incerta, sempre pronta a sfuggirci di mano… e quelle scarpe sono lì, a testimoniarlo, ormai appese come frammenti di esperienze passate…”
Seth, dal (pro)fondo della classe, con quell’espressione di chi sta per postare un meme virale, alza la mano e sgancia la bomba:
“Prof, with all due respect, ma quelle scarpe non sono simboli filosofici. Sono lì per segnalare dove si spaccia droga.”
Silenzio…
Poi la classe esplode in risate virali. Io, ammaccato come un epitaffio su una lapide romana, li osservo con il mio ragionamento filosofico appena “shadowbannato” dalla dura realtà. Boom. Fine del volo filosofico. La classe in delirio, io in crisi esistenziale.
Ecco cosa succede quando cerchi di insegnare la caducità della vita… ai tempi di Seth… io che spaccio Seneca, qualcuno qualcos’altro… Forse dovrei cambiare “fornitore”… o magari solo aggiungere qualche hashtag.

10 ottobre
Ma perché i miei alunni ormai sono diventati dei POST ambulanti? Insomma, parlano solo per acronimi, come se vivessero dentro una chat perenne! Non so se sia più un’evoluzione o un esperimento linguistico estremo…
La cosa più interessante? Decifrare i loro acronimi è diventato il mio personale esercizio da archeologo digitale! Mi sento un po’ come Champollion di fronte alla Stele di Rosetta: dipende tutto dal contesto!
Se sono in classe con lo sguardo perso, TTYL non significa “Talk to you later”, ma Temo Tu Yoda Leggerai (quando gli chiedo di studiare il latino…)
Se stanno andando verso la porta con la borraccia in mano, BRB non è “Be right back”, ma Bevo Rapidamente Bibite
OMG? Beh, in quel caso è Ormai Mi Grattugio (anche se non ho ancora capito bene cosa…)
E quando vedo quelle facce perplesse davanti alla grammatica di Cesare e Virgilio, IDK non è “I don’t know”, ma In Dubbi Kontinui (che in effetti è già un bel traguardo!).
E intanto un’altra settimana di scuola americana volge al termine e… SLGC – Oggi è venerdì, e domani posso DA, de-acronimizzarmi.
“P.S.: Nessun acronimo è stato storpiato senza consenso, e ovviamente SLGC non è l’acronimo della formula della chiesa a cui rispondiamo con ‘sempre sia lodato’. In realtà, significa: ‘Sono Libero, Grazie (al) Cielo!’
…O forse no?”
11 ottobre
Marcellus eris… Il verso di Virgilio aleggia nella classe ormai deserta. Le lampade alogene illuminano i banchi di una luce innaturale. Nell’aria c’è odore di scuola vissuta, sa di snack, di AirPods scarichi e di custodie di cellulari. Sto raccogliendo i miei appunti quando Madison si avvicina. Deve essere tornata in aula con passo leggero, come un post appena pubblicato che scivola nella timeline senza dare nell’occhio.
“Prof, ma perché Marcellus? È come se fosse condannato in partenza, senza via di scampo. Il suo destino era già scritto, no?”
Sorrido senza energia: “Marcellus eris” significa proprio questo: “Sarai Marcellus”. Un ragazzo pieno di promesse, che però muore giovane, prima di poter realizzare la sua grandezza. È una sorta di promemoria che ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza, e quanto poco possiamo fare contro il destino.”
Madison ci pensa un attimo e poi, con un mezzo sorriso, ribatte: “Ma non è un po’ quello che succede a noi oggi? Lasciamo tracce ovunque online, con i nostri profili, foto, pensieri… anche quando non ci saremo più, rimarrà tutto lì. Come una versione digitale di noi stessi, no? Oggi però non abbiamo bisogno di un poeta: i nostri social fanno tutto da soli! Anche quando moriremo, ci saranno ancora i nostri post, le foto, i messaggi. Non è una specie di ‘immortalità’?”
“È vero, ma il poeta sublima i ricordi, li rende eterni…”
Madison si stringe nelle spalle e sorride: “Ma poi non se li fila nessuno, a parte noi che dobbiamo studiarli per il test.”
Le sue parole rimangono nell’aula deserta, e io mi ritrovo a chiedermi se, in effetti, la nostra versione di “immortalità” non sia proprio quella che stiamo costruendo ogni giorno, un post alla volta.
13 ottobre
L’iPhone non esisteva, per condividere una canzone si passavano le cuffiette del Walkman, e nelle autoradio rimbombavano le note di Hey Ya! degli OutKast o Vertigo degli U2. La sera, ci si collegava a internet sperando che il modem non interrompesse la telefonata di casa. Le chat di MSN erano il regno delle conversazioni segrete, mentre Il Signore degli Anelli trionfava al cinema e Lost iniziava a tenerci tutti incollati allo schermo.
Era un’epoca di passaggi: dalle videocassette ai DVD, dalle lettere cartacee alle email. E in mezzo a tutto questo, c’era Facebook, che iniziava a spuntare tra i banchi delle scuole e nelle chiacchiere degli studenti.
Ero un giovane professore in Italia, e i miei alunni cominciavano a dirmi: “Prof, deve assolutamente aprire un profilo Facebook, altrimenti resta indietro!” Mi sentivo accerchiato. Lo avevano tutti: amici, colleghi, conoscenti. Ma io ho resistito, con tutte le mie forze, fino al 2014, quando lavoravo come coordinatore per un programma internazionale presso l’università. Il mio supervisor mi disse: “Guarda che i ragazzi usano Facebook per tutto! Se vuoi comunicare con loro, ti serve un account.” E così, anche il prof ha ceduto. Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames… a che cosa non spingi l’animo degli uomini, maledetta brama d’oro!
Ora FB lo uso per scrivere. Gli amici che mi chiedono perché posto storie brevi invece di scrivere sul blog, ricevono sempre la stessa risposta: Nullo die sine linea. Cicerone ci ricorda che questo detto latino viene da Plinio il Vecchio, il quale lo attribuisce al pittore Apelle, che non lasciava passare un giorno senza tracciare una linea, ovvero senza esercitare il suo mestiere.
E a chi mi dice che ormai Facebook è stato spremuto come… un’arancia vecchia al bar, quella che gira da giorni sullo spremiagrumi e non dà più neanche una goccia, rispondo con un sorriso. Lo so, Targhetta, Bussola e Galiano hanno cavalcato l’onda quando il mezzo era ancora frizzante. Io invece? Io sono sempre stato un ritardatario cronico: usavo le cassette del Walkman quando tutti compravano i CD, ho scoperto i CD quando ormai dominavano gli mp3, e ho comprato il mio primo mp3 reader quando gli altri già usavano Spotify. E ho creato un account Facebook quando tutti sono passati su Instagram o TikTok…
Intanto, i miei alunni che mi esortavano a stare al passo con i tempi si sono sposati, hanno bambini, un lavoro e vite che rimbalzano nella frenesia del logorio moderno. Come faccio a saperlo? Li leggo su Instagram.
17 ottobre
La scuola, all’alba, è avvolta in un silenzio denso, quasi palpabile. I pochi studenti che attraversano i corridoi somigliano a foglie d’autunno sospese in un vento che non riescono a controllare. L’ordine con cui arrivano ricorda quello di un concerto: i primi a varcare l’ingresso sono gli introversi, quelli che vivono nei margini dei gruppi sociali, o gli influencer di nicchia, quelli del “pochi ma buoni”. Col passare dei minuti, faranno il loro ingresso gli studenti con qualche centinaio di follower, e infine, come in ogni spettacolo che si rispetti, le star. Arrivano quando la scuola si è già risvegliata, trasformata in un formicaio in piena attività. Ma per ora, ci sono solo loro, i fantasmi del mattino, figure silenziose che si trascinano dietro appunti stropicciati e problemi troppo grandi per la loro età. Ripassano nozioni o forse frammenti di vita, assomigliano a tanti tasselli di Tetris che non riescono mai a incastrarsi perfettamente. È l’incertezza dell’adolescenza, un disordine che riconosco come una sbornia che mi da ancora la nausea.
Dal bagno una ragazza sta cantando Linger dei Cranberries, la voce spezzata: “Did you have to let it linger?” Le parole graffiano l’aria fredda d’autunno. È una Gioia Spada qualunque, come ce ne sono tante in ogni scuola. Questi ragazzi hanno tutto e questo li rende vulnerabili… In fondo sono un po’ rotti, e attraverso le loro crepe filtra una luce che svela minuscoli frammenti di bellezza.
18 ottobre
La mensa delle high school americane è un mondo a parte, dove gruppi di studenti si raccolgono per etnia, ma in realtà sono tutti connessi da un’unica rete invisibile: quella dei social. I ragazzi sudamericani ridono tra loro, i loro pensieri veloci come i post che scambiano in spagnolo. Al centro, un gruppo di studenti asiatici mangia in silenzio, concentrati sui loro piatti. Una ragazza seduta accanto a loro è completamente immersa nel telefono. Le bacchette si muovono veloci tra le dita mentre guarda un mukbang, dove una giovane donna divora grandi piatti di cibo sullo schermo. Vicino alla finestra, un gruppo di ragazzi afroamericani discute anim
atamente; i loro capelli sono un tripudio barocco che va dal cotonato alle treccine intarsiate con perline di plastica colorata ed extension attorcigliate come serpenti di antichi miti pagani. Le “Starbucks girl” occupano il centro della mensa; indossano magliette tutte uguali, leggings aderenti e Crocs o Adidas basse, il nuovo trend di Tik Tok. Ridono sguaiate mentre sorseggiano generose poppate di mocaccini deluxe dalle caraffe griffate, tra una risata e l’altra controllano gli smartphone interagendo con emoticon soffici come marshmallow. I ragazzi della squadra di football, marcantoni di due metri, le guardano scambiandosi cenni d’assenso e facendo gli occhi da fessi, pronti ad invitarle con un DM, un direct message, al prossimo after party.
In un angolo, gli studenti di ESOL vivono il loro mondo parallelo, immersi tra panini al tacchino, videogiochi e selfie. Anche loro sono parte di quella rete sotterranea che scruta e condivide, mescolando il reale e il virtuale. La mensa scolastica delle high school è un microcosmo di culture, sogni e schermi luminosi, forse il riflesso di una nuova America.
21 ottobre
Quando ho iniziato a insegnare, i miei studenti si prendevano cura dei loro Tamagotchi come se fossero creature reali, il sabato i più fragili si stordivano con canne o acidi, prima di andare al pub o in discoteca. Qualche decennio prima, tra gli anni ’70 e ’80, c’erano storie come quella di Christiane F., che parlavano di giovani alle prese con l’eroina. Oggi, le droghe sono diventate più “dolci”, soffici, colorate—vapes, sizzurp e altre misture alla moda—ma forse è proprio perché la vita è diventata più amara.
Lo sizzurp è una miscela di sciroppo per la tosse (contenente codeina, un oppiaceo) con Sprite e caramelle. La codeina deprime il sistema nervoso centrale, riducendo il dolore e inducendo uno stato di calma, mentre la prometazina provoca sonnolenza. Il risultato? Una sedazione profonda, una fuga dalla realtà che isola i ragazzi dietro una nuvola di zucchero e fumo.
La vita oggi è davvero più amara, o siamo noi che abbiamo cambiato il modo di affrontare il malessere? Forse non importa se si nasce con un Tamagotchi in mano o con un iPhone: Leopardi lo aveva già capito. ” è funesto a chi nasce il dì natale…” Il tentativo sembra sempre lo stesso… dimenticare di esistere, anche solo per un attimo, per trovare un po’ di pace… e il mio senso di impotenza è come scorrere un feed infinito sui social: vedo tutto, ma non posso fare molto. Ogni post è un frammento di realtà che non posso cambiare, ogni gesto dei miei studenti un like che non arriva mai al cuore del problema.
23 ottobre
Qualche volta, il venerdì, prima di tornare a casa, mi fermo a guardare una partita di calcio femminile della nostra scuola. Qui in USA, a livello giovanile, specie per le ragazze, è uno sport popolarissimo, e gli spalti sono stipati di famiglie e tifosi. Il mio sguardo si incaglia sempre su Melany, il capitano della squadra, una delle migliori studentesse della mia classe di latino. Sul campo, Melany ha una presenza che non può passare inosservata. Corre come se non esistesse un domani, e nei suoi occhi vedo un lampo che a volte mi fa paura.
Mi ricorda un’Erinni, le divinità vendicatrici implacabili, che inseguivano i colpevoli senza mai fermarsi. Non avevano pace, solo una missione da compiere: inseguire senza tregua. E Melany, con quella determinazione feroce, somiglia proprio a una di loro. Non c’è felicità nel suo sguardo, ma una grinta incrollabile, una forza che sembra dire che nulla la potrà fermare.
Io quella determinazione non l’ho mai avuta. Alla sua età vivevo di sogni magri che non avevano fame di vittoria. Per Melany non è una questione di passione: è un imperativo. Ogni allenamento, ogni partita, ogni compito in classe è una battaglia da vincere, non un’esperienza da vivere.
Quando ha fallito l’unica versione della sua vita, mi ha affrontato a muso duro, ma l’ho vista stanca, con gli occhi circondati da venature rosse, e per un momento ho intravisto l’inganno: il peso che porta sulle spalle. Quando le ho detto che sbagliare è umano, errare humanum est, mi ha risposto che non era lì per essere consolata, ma per capire come migliorare.
Viviamo in un’umanità che premia la determinazione, ma il prezzo da pagare è spesso l’umanità stessa. Ma queste ragazze non sono Erinni, sono esseri umani. Fermarsi, respirare e accettare gli errori che portano a una medaglia di bronzo non è una debolezza, ma la parte formativa del viaggio.
25 ottobre
La penultima settimana di ottobre sta rotolando verso il traguardo come un respiro profondo che si distende sulla strada piana. Il traffico del venerdì sera è soffice, sopra di noi nuvole zuppe di pioggia si gonfiano di porpora e d’oro. Le foglie rosse e gialle danzano ai bordi della strada, e il neon di un distributore di benzina solitario si staglia lungo la linea dell’orizzonte. La macchina davanti a me si muove scorbutica come una versione di Tacito: la seguo con un occhio aperto e uno socchiuso, lasciandomi cullare dal ritmo lento e quasi ipnotico della sera. Solo davanti al semaforo rosso noto lo sticker sul paraurti e mi perdo nei ricordi…
Quando insegnavo ancora in Italia, ogni mattina la scuola era circondata da motorini che arrivavano come sciami d’api all’alveare. Scooter abbandonati e ammassati nei parcheggi, l’odore di miscela bruciata che riempiva l’aria e seccava la gola, quel ronzio collettivo di motori a due tempi che accompagnava l’inizio e la fine della giornata scolastica. Era una sorta di rituale: il “prrr prrr” dei motorini che sciamavano via, come una dichiarazione d’indipendenza rumorosa, orgogliosa…
Riapro gli occhi e fisso lo sticker sul paraurti della macchina che mi precede. Il semaforo diventa verde…
Qui, negli Stati Uniti, il “rito di passaggio” è diverso e inizia prima: la patente di guida si può ottenere a 16 anni nella maggior parte degli stati, e in alcuni addirittura a 14 (come in South Dakota, North Dakota e Montana!). Il percorso verso la “driver’s license” è un’avventura fatta di test, guide assistite e una serie di tradizioni scolastiche.
Per prima cosa, c’è il corso di guida, spesso organizzato dalle scuole come programma extracurriculare. Gli studenti non imparano solo le regole della strada, ma anche lezioni fondamentali su sicurezza e sugli effetti dell’alcol e delle droghe sulla guida, con video educativi e talvolta incontri con poliziotti locali per spiegare le conseguenze di comportamenti irresponsabili. È un misto di educazione stradale e, diciamocelo, anche un po’ di prevenzione spinta.
Poi arriva il test teorico, che si sostiene presso la MVA, DMV o BMV (ogni stato ha un nome diverso per la motorizzazione). Si tratta di un esame a risposta multipla con domande su segnaletica, regolamenti e situazioni di guida comune. I ragazzi che lo superano ricevono il famoso “learner’s permit,” una sorta di foglio rosa che permette loro di guidare, ma solo in compagnia di un adulto, solitamente un genitore.
A questo punto, inizia una fase quasi epica per le famiglie americane: i genitori devono accompagnare i figli per un minimo di 60-70 ore di guida (varia da stato a stato), annotando con precisione orari e percorsi in un log book, una specie di diario di bordo della Enterprise. Inoltre, devono completare un certo numero di guide obbligatorie con una “driving school” (scuola guida) che ha istruttori certificati per insegnare manovre specifiche come parcheggi, inversioni, frenate d’emergenza e tanto altro.
Dopo aver accumulato abbastanza esperienza su strada, il giovane aspirante automobilista torna alla motorizzazione per il “road test,” l’esame di guida pratica. Una volta superato anche quello, finalmente ottiene la “driver’s license,” la patente vera e propria.
E qui spunta un’altra tradizione
tipicamente americana: per festeggiare i sedici anni e la loro “promozione” a guidatori, il PTA (il comitato dei genitori) spesso recapita ai ragazzi una cartolina di congratulazioni. Sopra c’è quasi sempre il disegno di una macchina colorata, qualche frase di augurio e qualche caramella o dolcetto. Negli Stati Uniti, ogni occasione è perfetta per distribuire un po’ di zucchero e tenere alto l’umore (e la glicemia!).
E allora, dopo tutta questa fatica, non resta che augurare al nostro neo-automobilista davanti a me: buona strada e che il Dio del traffico sia sempre dalla tua parte!
Nulla da fare… la macchina davanti a me continua a procedere scontrosa, come una verifica di Tacito…
26 ottobre
Anni fa, insegnando in una scuola “low performing,” ho scoperto qualcosa di inaspettato: molti dei miei studenti afroamericani condividevano un sogno semplice e potente – diventare postini. Incuriosito, chiesi a uno di loro cosa significasse per lui quel lavoro, e la sua risposta mi aprì gli occhi. Mi disse che lavorare alle poste significava stabilità, rispetto, una porta d’accesso alla classe media – un’opportunità di costruire un futuro che a tanti altri era negato.
USPS, il Servizio Postale degli Stati Uniti, ha rappresentato per generazioni una via verso una vita dignitosa, stabile, e ben retribuita, offrendo ruoli con potenzialità di crescita che molti altri percorsi non fornivano. Negli anni ’40, con le battaglie per i diritti civili e le necessità del periodo bellico, USPS ha aperto ulteriormente le sue porte ai lavoratori afroamericani, fino a vedere alcuni di loro assumere posizioni di rilievo nei principali uffici postali del Paese.
Anche uno dei miei cantautori preferiti, John Prine, ha percorso con orgoglio la strada del postino prima di diventare famoso. Girando per Chicago con la sua borsa piena lettere, Prine osservava la vita quotidiana delle persone e trovava ispirazione nelle loro storie. Alcune delle sue canzoni più celebri, come Sam Stone e Hello in There, portano i segni di quell’esperienza, di quell’umanità che aveva colto proprio consegnando la posta. Prine ha dato voce alle vite semplici e dimenticate, facendo del lavoro del postino non solo un mestiere ma un modo per vedere e comprendere il mondo.
Oggi, il 29% dei dipendenti USPS è afroamericano, un dato sorprendente rispetto al 12,6% della forza lavoro nazionale. Anche il divario salariale tra lavoratori afroamericani e bianchi è inferiore rispetto ad altri settori, a testimonianza di come USPS continui a promuovere inclusione e parità.
Negli anni recenti, tuttavia, USPS ha dovuto affrontare sfide non indifferenti. Durante l’amministrazione Trump, il servizio postale ha visto tagli ai finanziamenti e limitazioni nel supporto federale, una mossa che ha suscitato timori per la sua capacità di operare con efficacia. Eppure, nonostante le difficoltà, USPS ha continuato a essere una risorsa essenziale, dimostrando la sua resilienza e il suo ruolo fondamentale per milioni di americani.
Con oltre 31.000 uffici in tutto il Paese, USPS è diventato molto più che un semplice servizio di consegna: offre servizi essenziali come il cambio assegni e transazioni elettroniche, proponendosi come alternativa accessibile e sicura alle banche tradizionali.
Per un futuro più inclusivo: Continuare a investire in USPS non solo preserva un’istituzione essenziale, ma rafforza la mobilità sociale americana, mantenendo viva la speranza di tanti che, con umiltà e determinazione, cercano un posto nel cuore della nostra comunità.
27 ottobre
In questa splendida giornata autunnale, con il profumo delle zucche nell’aria e Halloween alle porte, a una settimana dalle elezioni presidenziali, cosa c’è di meglio di un bel tema leggero… la pena di morte in USA.
Ventitré stati l’hanno abolita, senza contare Porto Rico e il Distretto di Columbia. Per i reati federali però la questione è diversa: in breve, un reato federale è un crimine che colpisce direttamente il governo degli Stati Uniti o viene commesso su territori che non appartengono a uno stato specifico, come ad esempio basi militari, i parchi nazionali o le riserve per intenderci. Per questi crimini, dopo la sentenza della corte suprema Gregg contro lo stato della Georgia, venne reintrodotta anche a livello federale, erano gli anni Settanta. Molti presidenti hanno però evitato di firmare i mandati di esecuzione… almeno fino a Donald J. Trump. Con lui, le esecuzioni sono riprese: Donald J Trump in soli quattro anni ha autorizzato la morte di tredici detenuti.
L’ultimo detenuto federale giustiziato è stato Dustin Higgs, con un mandato firmato da Trump a pochi giorni dall’insediamento di Joe Biden. La vicenda di Higgs merita una storia a sé… ve la lascio nei commenti.
È interessante notare che molti degli stati dove vige ancora la pena di morte, sono anche quelli che si dichiarano “pro-life,” cioè contrari all’aborto, perché a detta loro sono per la difesa della vita…
28 ottobre
La ragazza è lì, incollata al cellulare. Guarda un video di TikTok, altro che Cicerone. Nel video, una mano lancia bottiglie e barattoli di vetro giù da una scalinata. Alcuni rimbalzano, altri esplodono al primo colpo. Bottiglia di Coca Cola: salta tre gradini, poi boom, schiuma ovunque. Barattolo di pomodori pelati: un rimbalzo scarso e si spappola in una cascata rossa. Lei guarda, con gli occhi annebbiati come se cercasse un guizzo in quei frammenti.
“Melany, ma cosa ti piace di questi video?” Mi risponde solo quando anche l’ultimo vasetto, pieno di biglie, si è frantumato, lasciando le palline a rotolare giù per gli scalini. “Io non lo so… c’è qualcosa di ipnotico nel vedere qualcosa che si spacca.”
Questi ragazzi, sono piccoli filosofi, basta solo trovare la chiave per leggerli, perché in fondo, si sta come barattoli sui gradini della vita, spinti da una mano dispettosa.. ed è subito sera.
30 ottobre
Sembrano personaggi usciti da una fiaba dei fratelli Grimm, ma immerse in una realtà di emoticon, emoji e stories su Instagram. Vivono in quartieri che sembrano un feed perfettamente curato, come se un algoritmo avesse eliminato ogni imperfezione: viali alberati e prati verdi, come filtri ben calibrati, e case monofamiliari con fiori che sbocciano come “mi piace” in una sequenza ordinata.
Queste ragazze, impegnate tra lacrosse e calcio, sono le eroine di una fiaba moderna. A differenza delle protagoniste dei Grimm, che affrontavano streghe nei loro abiti svolazzanti e mantelli scuri, le Starbucks Girls si muovono tra leggings neri e gloss alla ciliegia, sempre perfette, come se indossassero un costume scelto dall’algoritmo stesso.
Le eroine delle fiabe combattevano contro incantesimi e misteri; le Starbucks Girls, invece, sfidano l’uniformità di un sogno americano levigato come un osso di seppia, cercando la loro identità oltre l’immagine perfetta che le circonda, come se ogni “scroll” fosse un tentativo di uscire da quel copione già scritto.
31 ottobre
Stamattina ero lì, bello carico, a spiegare un passaggio del De Bello Gallico, quello sui druidi – sì, proprio quel capitolo appassionante come una coda in autostrada ad agosto. Quando, a un certo punto, sento un rumore strano. Tipo… un animale nella selva germanica? Mi avvicino. Macché, era Seth. Russava di gusto. Sì, non solo si era appoggiato al banco, ma dormiva alla grande, con tanto di fase REM e “Losing My Religion”.
Lo sveglio e lui, mezzo intontito, si passa una mano tra i capelli e mi ringrazia. Ma di cosa? Gli chiedo più arrabbiato di Cesare con Vercingetorige. Lui, con una calma olimpica, mi spiega che stava facendo un “power nap”. Un… cosa?!? Un pisolino ricaricante? Neanche fosse l’ultimo modello di smartphone.
Mentre sono ancora lì a cercare di capire se mi sta prendendo per i glutei, nella classe si accende una discussione generale: tutti sembrano essersi svegliati dal torpore della brughiera gallica, e discut
ono di gusto dell’utilità del “power nap”. Io tento di riportarli alla realtà, spiegando che, per come la vedo io, si chiama pennichella e che a scuola non si può fare. Ma loro no, si indignano! Mi danno del vecchio, dell’obsoleto, uno che li spreme come limoni nella Silicon Valley, dove invece – mi spiegano con aria da saputelli – ci sono le nap rooms e menti libere che fanno tutti i power nap di cui hanno bisogno.
Morale della favola: io alla loro età rischiavo di finire dal preside per una mezza pennichella, loro si fanno i power nap e mi fanno pure capire che devo aggiornarmi. Eh, mannaggia a loro… però almeno una cosa posso dirla a Seth: con questo power nap, la sufficienza… se la sogna!
31 ottobre, sera
Ho scritto tanto della sala professori. In fondo, è il classico non luogo, un punto di sosta dove si incontrano – e si scontrano – aspirazioni, delusioni e sogni degli insegnanti… Quelli di chi ci passa per un quadrimestre e quelli di chi, ci è rimasto intrappolato una vita intera. La sala professori è come una stazione che non porta da nessuna parte. Tutti stanno lì, ma con i minuti contati.
Un collega che si attarda davanti alla fotocopiatrice: occhiate torve. La collega che fruga nella borsa per trovare qualche spiccio per il distributore, bloccando la fila: sguardi stizziti. Il collega che si mette a disquisire su un alunno, improvvisando un consiglio di classe estemporaneo: malcelata insofferenza.
In sala professori noi insegnanti siamo piccoli Proust. Assaporiamo con meraviglia il passare ineluttabile del tempo, tra una classe e l’altra, aspettando una campanella che ci porti altrove.
Discover more from Lapis Et Lux
Subscribe to get the latest posts sent to your email.