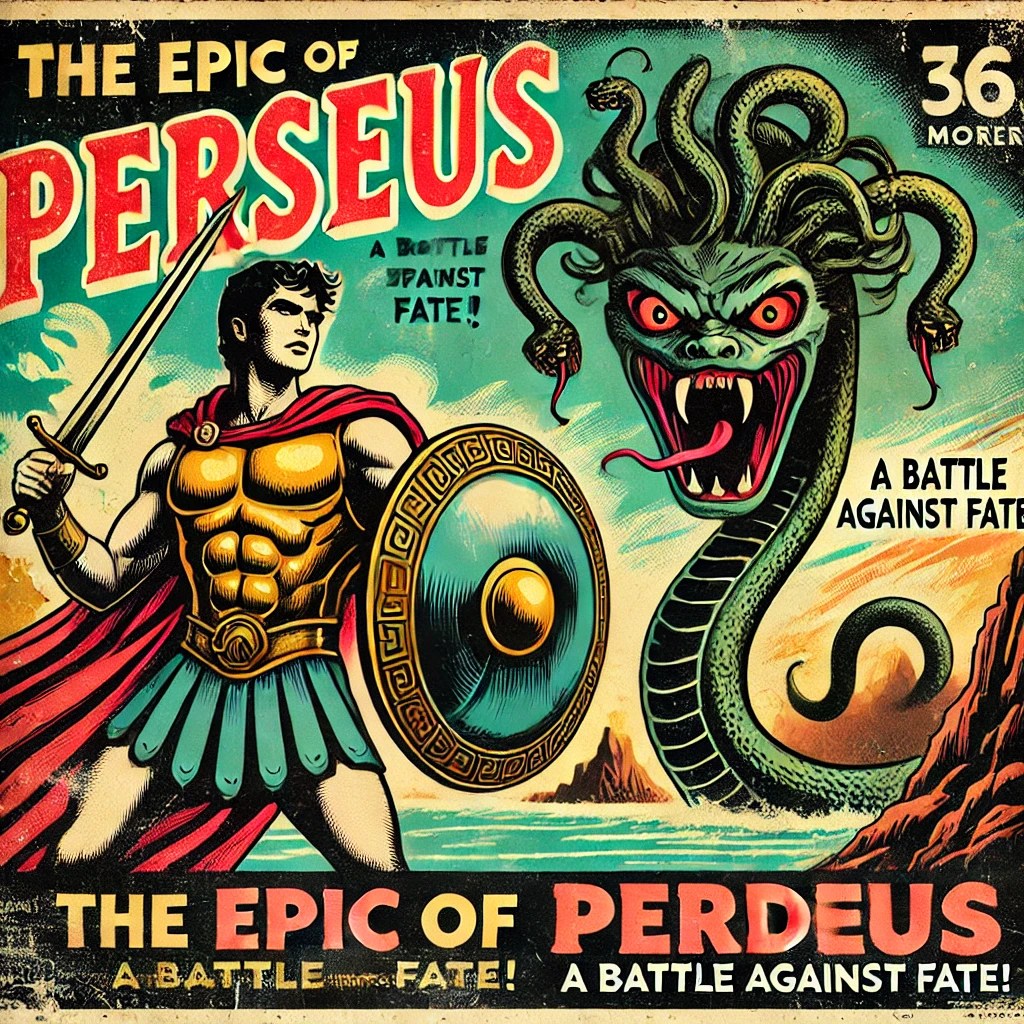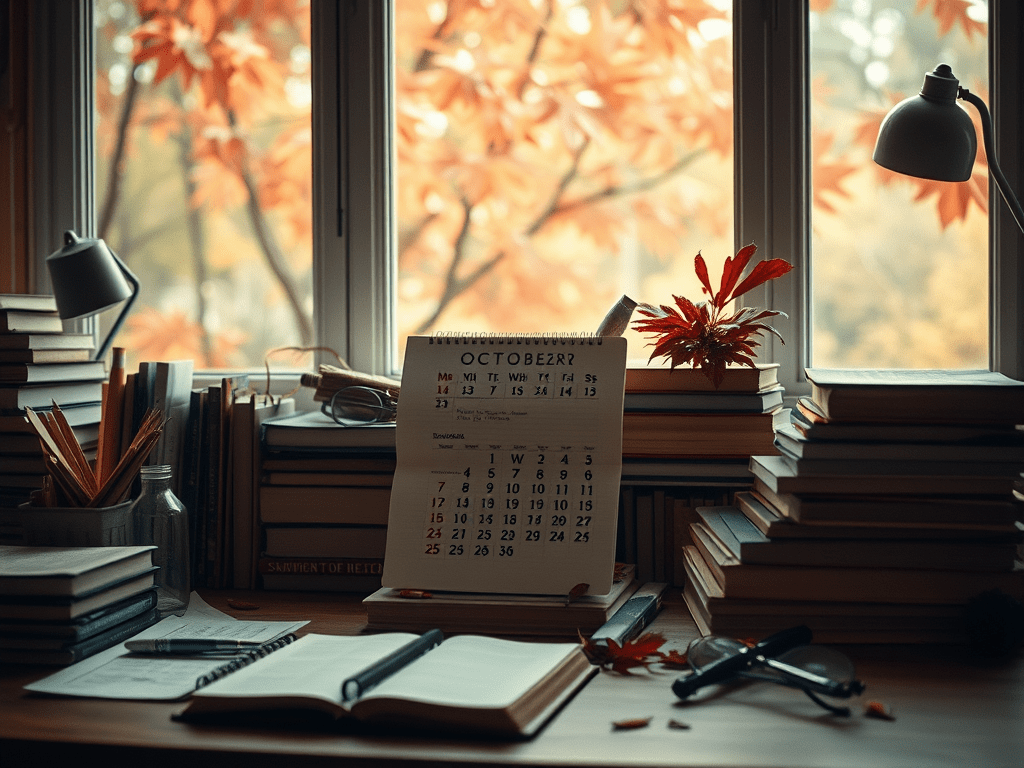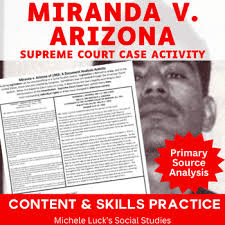Questo mese ho raccontato di cultura americana, scuola e, qua e là, delle mie amate liste da otto. Pensieri lanciati come foglie d’autunno: leggeri, sparsi, senza troppa pretesa di ordine. Le liste, otto punti fissi, sono per me un esercizio di stile divertente, un modo per mettere ordine nel caos dei pensieri. Ma non mi sono fermato a quelle.
Ho provato a intrecciare sprazzi di vita quotidiana, riflessioni leggere e qualche provocazione, come si fa quando si chiacchiera tra amici.
Qui ripropongo un assaggio di tutto, anche per chi non frequenta Facebook. Chissà, potreste trovare uno spunto, o forse nulla. Ma tant’è.
6 novembre
Guarda, non mi va di parlarne adesso. Sì, lo so, è l’argomento del giorno, ne parlano tutti, tutti hanno capito, ma… senti che bella giornata, no? È incredibile il caldo per novembre, sembra una di quelle pubblicità delle spiagge che ti arrivano quando stai già con la sciarpa al collo. Ah, e le foglie continuano a cadere, come se avessero un piano strategico per ricoprire la strada ogni mattina
Ieri sera ho iniziato un libro nuovo, un romanzo… Demond Copperland! Ma no, ti ho detto che di quello non ne voglio parlare. Non per altro, eh, solo perché… ho un’idea, ma non è ancora un’idea vera, è tipo…a concept of an idea. Come quando vedi una macchia sul muro e pensi “forse potrei trasformarla in un murales” ma poi ti rendi conto che è solo un difetto dell’intonaco.
Capisci cosa intendo? No? Neanche io. Ma tant’è!
7 novembre
Più o meno, le materie che troviamo al liceo in Italia sono le stesse anche nelle high school americane. Certo, c’è qualche differenza. La più evidente? La filosofia. Da noi in Italia è una colonna portante, una disciplina che accompagna tutto il triennio delle superiori e forma pensiero critico, logica e analisi. Qui negli USA, invece, quando va bene è solo una piccola materia semestrale… come dire, quasi un contorno.
Ma gli americani sanno vendere la scuola in modo tutto loro!  Prendiamo “inglese”: non si chiama inglese, ma Language Arts – l’arte del linguaggio, una definizione che ha quasi un’aria nobile, come se scrivere un tema fosse un’opera d’arte in sé! Oppure ancora meglio, con l’acronimo ELA. E “storia”? Troppo semplice, qua si chiama Social Studies – studi sociali, che fa sembrare la materia più una scienza pratica che una cronologia di eventi.
Prendiamo “inglese”: non si chiama inglese, ma Language Arts – l’arte del linguaggio, una definizione che ha quasi un’aria nobile, come se scrivere un tema fosse un’opera d’arte in sé! Oppure ancora meglio, con l’acronimo ELA. E “storia”? Troppo semplice, qua si chiama Social Studies – studi sociali, che fa sembrare la materia più una scienza pratica che una cronologia di eventi.
In un certo senso, il loro sistema è una lezione di marketing applicata: il packaging conta! E noi italiani, da buoni filosofi, ci interroghiamo su cosa ci sia dentro, mentre gli americani ti convincono che dentro quel “language art” c’è quasi la ricetta della creatività!
9 novembre
Lo so, lo so, il “latinorum” qui in America… Quante volte me l’hanno detto: ma cosa possono mai imparare i ragazzi americani di Latino? Non provare a fregarmi, eh! Guarda che il cugino di un amico del fratello di un conoscente del vicino di casa, grande esperto di scuole americane, mi ha detto che qui non si impara proprio nulla. Latino in America? Ma va, figurati!
Ripenso a tutto questo, a quasi quindici anni di commenti ricevuti sul web, nel blog, da voci naturalmente anonime mentre correggo la traduzione di Sarah, una studentessa del primo anno. Oggi Sarah e i suoi compagni hanno affrontato un compito a sorpresa (Manes tuorum maledicti!): una traduzione intitolata The Sad Fate of Atreus, e non posso fare a meno di sorridere. Mi fanno tenerezza questi ragazzi americani, che si avvicinano al latino con la mente colorata, piena di immagini e sogni, pronti a esplorare la classicità con una curiosità irriverente. Li immagino immersi negli spazi sconfinati di questa giovane nazione, che guarda al passato non come un Renzo qualunque col cappello in mano, ma con un’energia vibrante, tutta americana.
9 novembre (sera)
Otto cose della mia scuola americana, chissà poi perché otto, che mi piacciono, che poi neanche so perché mi piacciono, ma so che mi piacciono comunque, e quindi mi piacciono…
1. I bus gialli: avete presente quei vermoni giganti a cherosene? Tintinnano, avanzano come dinosauri moderni, e trasportano orde di studenti mezzi zombie, ognuno con le cuffiette ben piantate nelle orecchie. 

2. Gli annunci dagli altoparlanti: rimbombano nei corridoi come se fossimo in una stazione dei treni sovraffollata. “Attenzione, studenti… la classe di chimica non è ancora esplosa, ma datele tempo.” 

3. La moda scolastica che sfida il buonsenso: ciabatte da piscina abbinate a calzini fino al ginocchio, giacche eleganti accanto a chi sfoggia kippah, hijab o addirittura un cappello da cowboy. Dimenticate il rigore stilistico di “donna Letizia”—la celebre rubrica dei magazine italiani che dettava bon ton e consigli di stile impeccabili. Qui invece… facciamo un po’ alla dick of dog! 


4. Gli armadietti che sbattono: improvvisate sessioni “rhythm and drums” mischiate ai botti di Capodanno, con fogli e cartellette che esplodono nel corridoio come fuochi d’artificio il quattro luglio. 

5. Le chiacchiere infinite: dalle teorie complottiste sul perché il prof di storia fa sempre i pop quiz, alle discussioni appassionate sull’ultimo episodio di quella serie che tutti guardano (tranne me, ovviamente). 

6. La mensa scolastica, versione ONU: ogni tavolo è un summit internazionale. Non più pizza e tacos, ma gli avanzi della sera prima presi nel doggy bag del ristorante su Allegany Avenue (il doggy bag è la tipica busta per portare a casa il cibo che non hai finito al ristorante la sera prima). Mentre qualcuno recita una preghiera, qualcun altro scatta selfie, e il resto combatte con un Wi-Fi più capriccioso di un influencer. 


7. Il caos tecnologico: prof che lottano con proiettori del secolo scorso, studenti che tifano come se fosse una finale di calcio, e altri che aggiornano le storie sui social raccontandosi la vita! 

8. La Pledge of Allegiance: una sorta di “preghiera alla bandiera,” dove tutti, chi più chi meno, ringraziano l’universo di essere nati o diventati americani.
Amo la mia scuola perché è un piccolo mondo fatto di imperfezioni. Perché proprio in questa disordinata armonia,mi ricordo che crescere è anche imparare ad amare il rumore della vita che accade senza un perché. 

10 novembre
Otto cose della mia scuola americana, chissà poi perché otto, che non mi piacciono, che poi neanche so perché non mi piacciono, ma so che non mi piacciono comunque, e quindi non mi piacciono…
1️ La prima ora alle 7:30: Chi ha deciso che studenti e insegnanti siano creature mattiniere è chiaramente un ottimista senza rimedio. Eppure, ogni mattina, alle sette e un quarto, devo essere in classe. Si apre il sipario, rain or shine…
2️ La campanella che sembra una sirena del porto: giuro, una volta stavo chiacchierando al telefono con un’amica in Italia e, appena la sirena ha ululato, lei tutta entusiasta mi fa: “Ma che bello, sei al porto sull’oceano?” No, cara, sono solo in un liceo americano, ma apprezzo il tuo romanticismo marittimo.
3️ La misteriosa assenza del distributore di caffè: qui non esiste l’iconico macchinozzo. Addio a quella tappa obbligata, con il caffè imbevibile ma che sapeva di complicità e aggregazione. Intendiamoci, non è il caffè nel bicchierino di plastica che mi manca, ma il rituale.
4️ Le interrogazioni orali: qui tutto è scritto, non esiste il voto orale (qualcuno mi ha detto che anche in Italia non c’è più, ma davvero?). Ma io, inguaribile amante delle tradUizioni, i miei studenti li interrogo comunque. Oh sì che li interrogo…
5️ Morning announcements: immaginatevi una voce che gracchia alle sette e mezza del mattino per informarci che “Oggi c’è la riunione del club di scacchi!” o che “le prove pomeridiane del drama club sono state cancellate”. E tu, che hai appena ingoiato l’ultimo sorso di caffè che sa di cloro (d’altronde l’hai preso dalla pompa di benzina dell’Interstate e cosa ti aspettavi?), cerchi di processare il tutto.
6️ Il pass per uscire dalla classe: un documento ufficiale da compilare ogni volta che un ragazzo deve andare… ovunque. Che poi io, sto blocchetto dei pass, non lo trovo mai nel disordine della mia cattedra, e poi mi scordo la data, e intanto cinque minuti di vita evaporano, inesorabili. Tempus fugit, dicevano i Latini. E te credo!
7️ Le observations: Quis custodiet ipsos custodes? Who will watch the watchmen? dicevano i Romani… e qui è un controllo continuo. Non è che insegno, no, mi cimento in prove degne di un teatro shakespeariano, con osservatori che sbucano all’improvviso. Il preside, il capo di dipartimento, un collega… entrano, ti guardano, prendono appunti, e io, da buon Decimo Meridio Massimo della situazione, continuo come se nulla fosse, armato solo di gesso e coraggio.
8️ Il bagno dei prof (sezione maschile): un unico, solitario bagno per tutto il piano. E c’è sempre la fila. E l’ansia. E la sirena che incombe. Ce la farò o no a tornare in classe prima del suono fatidico? È una roulette russa, ogni volta.
 Eppure, nonostante tutto questo circo quotidiano, c’è qualcosa che mi tiene legato come un’ostrica a questo mondo americano. Perché, a ben vedere, la quotidianità è fatta anche di dettagli insignificanti, e senza di loro la giornata non sarebbe la stessa. E sapete una cosa? Non mi (dis)piace. Sì, sì…anzi mi piace.
Eppure, nonostante tutto questo circo quotidiano, c’è qualcosa che mi tiene legato come un’ostrica a questo mondo americano. Perché, a ben vedere, la quotidianità è fatta anche di dettagli insignificanti, e senza di loro la giornata non sarebbe la stessa. E sapete una cosa? Non mi (dis)piace. Sì, sì…anzi mi piace.
11 novembre
Walmart e Target sono due catene di supermercati molto famose negli Stati Uniti. Walmart è noto per i suoi prezzi bassi e l’atmosfera rilassata: il classico posto dove puoi fare la spesa in pigiama senza sentirti fuori luogo. Target, invece, ha un tocco più chic, con prodotti leggermente più costosi e un ambiente che ti fa venire voglia di vestirti in modo presentabile. “Oh no, non ho trovato il latte da Walmart… ora mi tocca fare la doccia e vestirmi seriamente per andare da Target!”
Nella mia scuola, gli studenti si dividono proprio tra quelli di Walmart e quelli di Target…
Lo studente da Walmart: Entra in classe con l’energia di chi ha combattuto contro la sveglia e le ha prese. Felpa sformata, tuta scolorita, scarpe che sembrano aver vissuto più avventure del Grande Lebowski. Non cammina: striscia, e ogni passo sembra un test di resistenza alla forza di gravità. Porta sempre con sé uno snack improbabile—pork rinds, cotenne di maiale essiccate—perché, in fondo, se non sgranocchi colesterolo a colazione, cosa vivi a fare? E poi la soda di sottomarca dai gusti improbabili, quella che ti fa chiedere se esista una laurea per inventare sapori con nomi tipo “blu elettrico” o “frutta non identificata.” I vestiti sono un manifesto scapigliato: buchi strategici e macchie d’olio che si rigenerano da sole e gridano all’universo: “Sì, ci ho provato, ma la vita ha avuto la meglio.”
Lo studente da Target. Arriva con una precisione svizzera, polo stirata e pantaloni cachi perfetti, lunghi d’inverno e corti d’estate, sempre con la giusta misura di eleganza scolastica. Le scarpe sono sempre lucide e ordinate; lei magari sfoggia stivaletti di camoscio o ballerine che sembrano appena uscite da un negozio di Soho. E non dimentichiamo il gloss alla ciliegia o il gel per capelli applicato con la precisione di chi potrebbe vincere un premio per l’attenzione ai dettagli. Ogni movimento è curato, come se il loro feed di Instagram fosse la linea guida anche per l’aspetto fisico.
Questi due universi convivono nella mia aula, si sfiorano e si evitano, come il grana e l’impepata di cozze, la Juventus e l’Inter, Target con il suo logo rosso e Walmart con il suo logo blu… E anche se sembrano mondi opposti, sono in fondo l’altra faccia della stessa America.
Il mondo è bello perché è avariato, e la mia aula lo è ancor di più. No, non avariata, bella! E mi piace proprio così, un passo (o una strisciata) alla volta.
13 novembre
Mr. D, ma a cosa serve studiare latino?
Prima di rispondere lascio sedimentare la domanda, come un infuso di karkadè che si colora e sprigiona aromi lentamente, rivelando la sua profondità sorso dopo sorso… Okay, immaginatevi Seneca oggi: un ‘life coach’ con un milione di followers, che posta frasi tipo “Ducunt volentem fata, nolentem trahunt” – il destino guida chi lo accetta e trascina chi si oppone. Sarebbe il re dei repost, altro che!
Oppure Cicerone, l’influencer OG che, in questo mondo pieno di fake news, ci terrebbe connessi alla realtà: “Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae” – la storia è testimone del tempo, luce della verità, vita della memoria.
Chissà, forse il caos di oggi avrebbe più senso se ci affidassimo alla testimonianza di chi ha calcato questo palcoscenico prima di noi.
16 novembre
«Ma scusa, perché insegnano ancora il latino? Non è una lingua morta?»
«Ma che stai mangiando per contorno?»
«Corn…»
«Corn, eh? Okay, corn, il granoturco dunque… da cornus, che in latino vuol dire “corno.” Non perché sei cornuto, ovviamente, ma per la forma appuntita della pannocchia. Vedi, il latino è così: pensi di averlo lasciato in un’aula polverosa, e invece lui ti aspetta, sornione, pure nel tuo piatto. Attento a cosa dici… non si sa mai dove riappare!»
18 novembre
E poi ci sono loro: i poster motivazionali nelle scuole americane. Sono come quei meme che spuntano ovunque sui social: nessuno sa davvero da dove arrivino, ma ci sono sempre. Dovrebbero darti la carica, come una playlist ispirazionale sparata a tutto volume, ma spesso lasciano solo principi di acufeni.
Gli americani, maestri del marketing, li piazzano ovunque: corridoi, aule, perfino nei bagni (perché, a quanto pare, l’ispirazione può colpirti ovunque…). E così, ogni giorno mi ritrovo circondato da frasi tipo “Reach for the stars!” o “Be the change you wish to see.”
Durante le lezioni, quando la classe sembra un’orchestra di sbadigli, mi capita di soffermarmi a guardarli e persino di scambiarci due chiacchiere, un po’ come quel pastore errante che parlava alla luna…
“Dream big, work hard!”
Una volta, da studente, mi è capitato di sognare di prepararmi per un test di matematica… e al risveglio la realtà mi ha colpito come una tramvata: il test non si era studiato da solo!
“Be the change you wish to see in the world.”
Se non volete essere il cambiamento, almeno evitate di fissare sotto il banco: sappiamo tutti che non state ispezionando il vostro inguine, ma il cellulare.
“Reach for the stars!”
Mi piace pensare che qualcuno ci provi davvero… ma poi mi viene in mente Maccio Capatonda e perdo la verve: “I tuoi genitori sono dei ladri: hanno rubato le stelle e te le hanno messe al posto degli occhi!”
“Mistakes are proof you are trying.”
Lo ripeto sempre: fare errori è normale. Ma farli sempre uguali, cento, mille, duemila volte? Quella è perseveranza…
“The only way to do great work is to love what you do.”
Ah, se solo il mio amore per la grammatica latina fosse un amore corrisposto!
“Your attitude determines your direction.”
Certo, ma a volte l’atteggiamento degli studenti sembra determinare solo una direzione: verso la porta dell’aula.
“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.”
Che poi, io le chiavi le perdo sempre: quelle della macchina, di casa, persino quelle della mia aula…
“Stay positive, work hard, make it happen.”
Stay positive, mi ripeto ogni mattina, mentre avanzo nei corridoi affollati di studenti che si muovono al rallentatore, come se fossero parte di un flash mob non autorizzato. Per ora, l’unica positività che ho ottenuto è stata quella al Covid, tre volte solo lo scorso anno.
Questi poster, lo ammetto, un po’ di compagnia me la fanno. Un tocco di ottimismo non guasta mai, anche se la vera motivazione spesso arriva a fine trimestre, quando i voti del registro elettronico mettono tutti con le spalle al muro, con o senza motivazioni… o, per dirla all’americana, without rhymes or reasons.
21 novembre
Negli sport delle scuole americane, entrare in una squadra non è automatico: bisogna guadagnarselo! Ogni anno si tengono i try-out, ovvero delle selezioni dove gli studenti mostrano le loro abilità davanti agli allenatori. Solo i migliori passano e vengono assegnati a una delle due squadre: varsity (la prima squadra, i top player, ovvero i ragazzi degli ultimi due anni) o junior varsity (JV) (la squadra dei futuri campioni, i primini pulcini insomma).
Far parte di una di queste squadre è un grande onore e un impegno serio. Le partite di varsity sono veri spettacoli: si giocano in stadi veri, con cheerleaders, musica, cibo in vendita (nachos, hotdog, popcorn), e il pubblico che paga il biglietto per assistere. Le trasferte possono essere anche molto lunghe, perché qui lo sport è una cosa seria, un grande evento comunitario che muove soldi e gente.
Ma attenzione: chi entra in squadra deve impegnarsi non solo sul campo, ma anche a scuola, perché voti bassi possono costare il posto in squadra. Per molti, lo sport è una porta per ottenere una borsa di studio all’università, quindi i try-out sono l’inizio di un sogno!
E poi ci siamo noi, i professori. Da contratto dobbiamo presenziare ad almeno due eventi sportivi all’anno disputati in casa. Vendiamo biglietti alle famiglie, facciamo da steward allo stadio, e cerchiamo di non farci troppo male. La nostra gara personale, però, è evitare di finire alle partite di football: sono infinite e, se piove, ti trovi lì, sotto il diluvio, con l’impermeabile che cede miseramente come nel peggior set di Ogni maledetta domenica. Non parliamo poi dei 30 gradi sotto zero al vento, quando invece dello “spirito scolastico” vorresti solo un bel vin brûlé trentino… Caldo, speziato, con i pinoli che galleggiano nel bicchiere e quel profumo di cannella e chiodi di garofano che ti fa dimenticare la pozzanghera nelle scarpe. Altro che “spirito scolastico”: qui serve spirito puro.
Eppure, alla fine della partita, quando la squadra vince e tutti esultano, quasi quasi mi dimentico le scarpe fradice e i piedi duri come rami d’abete. Perché, guardando quei ragazzi ammaccati ma felici, mi ricordo perché ho scelto questo lavoro.
21 novembre (sera)
Otto cose della mia vita americana, chissà poi perché otto, che mi piacciono, che poi neanche so perché mi piacciono, ma so che mi piacciono comunque, e quindi mi piacciono…
1. Il cielo sconfinato: sempre un po’ più grande di quanto serva. Le albe rosa pesca che sembrano uscite da una pubblicità di cereali e i tramonti che ti fanno venire voglia di citare poeti che non hai mai letto. 

2. Le persone che ti chiedono “How are you?” anche al drive-thru: a volte suona come un automatismo, ma altre volte è bello far finta di pensare che ci credano veramente.
3. Le decorazioni natalizie esagerate: renne gonfiabili grandi come Panda, luci che farebbero invidia alla NASA e Babbi Natale arrampicati sui tetti come ladri maldestri. Tutto rigorosamente acceso a novembre, perché l’anticipo è tutto. 


4. La libertà di vestirsi un po’ come cazzo ti pare: in pigiama al supermercato, coi sandali sopra i calzini al cinema, o col cappello da cowboy in palestra. Nessuno ti guarda strano, anzi, magari ti fanno pure un complimento. “Nice crocs, dude.” 


5. I cibi dai gusti bipolari: gelato al bacon, zucca speziata, marshmallow tostato… ogni volta mi perdo minuti interi davanti agli scaffali del supermercato pensando “E se…?” 

6. Le confezioni di latte enormi: quelle da un gallone che in Italia farebbero sembrare la cucina troppo piccola ma che fanno molto sitcom ogni volta che li tiri fuori dal frigo. 

7. I bancomat drive-through: dove puoi prelevare, depositare e, perché no, comprare criptovalute mentre sei ancora in pigiama. Basta un clic e ti senti già un investitore di Wall Street… versione rilassata ovviamente. 


8. Il fatto che tutti ti chiamano “man”: il barista di Starbucks che ti chiede “How’s it going, man?”, il tecnico della fibra ottica che ti dice “Don’t worry, man, I got this,” e pure il ragazzino di sette anni che ti urla “Thanks, man!” dopo che gli hai passato una palla. Ti senti sempre un po’ protagonista di un buddy movie anni ‘80. 

Amo questa mia vita americana perché, tra un cielo sconfinato e una fetta di pumpkin pie, mi ricordo che la casa, come dicevano gli antichi romani, est ubi cor est (è dove si trova il cuore). 

22 novembre
Otto cose della mia vita americana, chissà poi perché otto, che NON mi piacciono, che poi neanche so perché NON mi piacciono, ma so che NON mi piacciono comunque, e quindi NON mi piacciono…
1. La disinvoltura con cui attaccano bottone: Sei al supermercato, stai comprando della pasta (chiedendoti perché costa il doppio che in Italia, tra l’altro), e subito uno si avvicina: “Ah, quella pasta! Ieri ho fatto una pasta Alfredo che faceva resuscitare i morti! E tu come stai? Cosa fai? Ah, sei italiano? Anche io! Beh, più o meno, perché il trisavolo del cugino di secondo grado di mio zio era italiano. Ciao, paesà!” E tu rimani lì, con il pacco di pasta in mano, a fissarlo (il pacco ovviamente), chiedendoti se esistono corsi per imparare a gestire questi incontri umani.
2. Un semplice starnuto e ti trovi al centro di una benedizione collettiva: Bless you – il commesso, Bless you – il cliente accanto, bless you – la nonnina in fondo alla corsia. E alla fine ti aspetti che dall’altoparlante arrivi un “Bless you” ufficiale. Forse dovrei starnutire di meno per evitare assemblee liturgiche spontanee.
3. L’ossessione per vendere alcol in gran segreto: Scaffali nascosti, ingressi separati, documenti controllati come se stessi cercando di comprare plutonio. Sembra di entrare in una setta massonica o di essere sul punto di scoprire il quarto segreto di Fatima.
4. La fissa per la temperatura glaciale: Uffici, cinema, scuole… tutto regolato per ospitare pinguini e mammut, non esseri umani. Portarsi un maglione in agosto è un atto di sopravvivenza.
5. Le pubblicità dei medicinali: Persone sorridenti che camminano a rallentatore su prati verdissimi, abbracciano cani, tirano aquiloni, sempre felici. (L’ho già detto che sono sempre felici?) Poi, all’improvviso… una voce fuori campo parte senza preavviso, a velocità supersonica: “Questo farmaco potrebbe causare nausea, vomito di sangue, perdita di capelli e unghie, collasso cardiaco, trasformazione in Gremlins…” E nel frattempo, loro, sempre a rallentatore, corrono tra i girasoli, sempre felici, sorridendo come se fossero appena stati assunti per una campagna della felicità eterna. Sempre felici… per sempre…
6. SUV grandi come condomini, con motori che nemmeno l’Enterprise di Star Trek… con motori tremila e duemiliardi di cavalli, tubi cromati, che quando sfrecciano accanto alla mia utilitaria, la fanno barcollare come la Provvidenza dei Malavoglia nel cuore della tempesta. Ogni viaggio in autostrada diventa un’epopea verghiana, con il mio piccolo veicolo in lotta contro onde di vento e schiaffi d’aria causati da questi giganti.
7. Il bagno con i buchi sotto le porte: C’è questo spazio, grande abbastanza da farti domandare “ma perché?”. Tu sei seduto sulla tazza, cercando di mantenere un po’ di dignità, ma chi si lava le mani può vedere il colore delle tue scarpe, i tuoi pantaloni abbassati e forse persino la tua disperazione. È un’esperienza surreale, un misto tra intimità involontaria e metateatro pirandelliano.
8. La mania per i “grandi sconti”: Esci per comprare il latte e torni a casa con sei litri di ketchup (che poi neanche ti piace) e ti chiedi: “Ma come caxxo è successo?”
Eppure… queste stranezze fanno parte del pacchetto. Come quelle canzoni che quando passano alla radio inizialmente ti danno sui nervi, ma poi ti entrano in testa e ti ritrovi a canticchiarle sotto la doccia. Sono sempre i dettagli che rendono uniche le esperienze, anche quando ti fanno sentire straniero. Perché alla fine… casa è dove impari a sorridere e rispettare anche quello che non capisci.
23 novembre
Perché ho scelto di insegnare qui in USA e in una scuola statale per giunta? Perché nelle mie classi i versi di Virgilio trovano una nuova eco. Gli esametri si intrecciano ai sogni di ragazzi che sono il riflesso di un’America multietnica: hijab dai colori vivaci accanto a All Stars dorate, turbanti arancioni e kippah ricamate di smeraldo e rosso rubino. Sono i figli di chi ha attraversato oceani e deserti, portando con sé frammenti di guerre lontane e il desiderio di ricostruire. Fuori, l’America rurale sembra un altro mondo: il profumo di burro e bacon che sfrigolano nelle cucine, i truck cromati che corrono vicino a villette con bandiere al vento. È un quadro di contrasti, ma anche un mosaico di storie che si incontrano.
Gli studenti, con i loro colori, suoni e odori, sono come un tramonto tra i palazzi di Theran, avvolti dalle nuvole leggere della poesia, dalle radici che si fondono nel ritmo ancestrale di una nenia familiare.
25 novembre
Ci sono momenti nella quotidianità di un quartiere americano in cui la logica, quella studiata su tomi di filosofia stoica, prende un ceffone dalla leggendaria strafottenza yankee del faccio un po’ come caxxo mi pare. Uno di questi momenti è il Pajama Day: il giorno in cui i bambini delle elementari vanno a scuola in… pigiama.
Succede due, tre volte all’anno, ma con una precisione svizzera.
Il quartiere si trasforma: un viavai di bambini in pigiama che corrono alla fermata del bus, genitori che li accompagnano in macchina sorseggiando caffè dalle tazze di cartone, con sguardi soffici e zuccherati come marshmallows al cioccolato.
Intanto, il piazzale della scuola diventa il set di un film surreale alla David Lynch. SUV che scaricano piccoli impigiamati in flanella con l’Orso Yoghi o i Minions, pullman gialli che riversano un esercito di bambini in pantofole, maestre in vestaglie da desperate housewives che si scambiano high five sotto un cielo plumbeo che minaccia pioggia. Tutto come se niente fosse.
E allora ti chiedi: Chi ha avuto questa brillante idea? Un genio del marketing dei pigiami? Uno psicologo bipolare con un esperimento sociale in sospeso? O il Mago di Oz, che si è stancato del suo castello e ha deciso di movimentare i plessi scolastici americani con tradizioni bizzarre?
Ma attenzione, perché il Pajama Day è solo l’inizio. Poi arriverà il Crazy Hair Day, dove i bambini sfoggeranno acconciature che neanche Lady Gaga quando ha cantato l’inno nazionale al superbowl. E a seguire il Mismatched Socks Day, in cui lo stile anarchico trionferà tra le caviglie. E infine il gran finale: il fundraiser del quartiere. Orde di bambini, in modalità retata della polizia, busseranno a ogni porta per venderti… di tutto. Sì, tutto: cioccolatini, candele, cavolfiori surgelati, rotoli di carta igienica decorati e, se sei fortunato, anche la casa del vicino (che poi naturalmente è il padre o la madre del bambino stesso).
E sì… peccato che nelle high school non si faccia il Pajama Day. Già mi pregustavo la scena: studenti che si presentano in vestaglia, lo sguardo scazzato e la barba di una settimana, in perfetto stile Grande Lebowski.
Ma poi mi fermo e vedo passarmi nel solaio impolverato del cervello Seth e Sam che, proprio la scorsa settimana, si sono effettivamente presentati così: vestaglia, barba trasandata, ciabatte da piscina con calzini di spugna (bianchi, ovviamente) e Il sorriso complice di chi sembra custodire un mistero inaccessibile, come cosa c’è scritto nei fascicoli segreti sull’assassinio di JFK.
Ed è lì che, come folgorato da una rivelazione, scuoto la testa: Giove Pluvio e tutti i fulmini tuoi! Ecco dove hanno imparato!
27 novembre
Ad agosto, con una certa irritazione perché il mio mindset italiano mi ricorda che potrei essere in vacanza, mi studio sempre il registro. D’altra parte, la maggior parte dei nomi dei miei alunni sono impronunciabili, meglio partire preparati. Poi, il primo giorno di scuola, faccio l’appello e comincio: “Xael?” E loro, con disinvoltura: “Actually, I go by Kenneth.”
E tu, con un’espressione da statua di cera, pensi: “Ma come Kenneth?! Ho passato l’intera settimana in macchina a praticare la pronuncia del tuo nome!”
Non parlo di Isabella che diventa Bella o Olivia che diventa Livi, ma di trasformazioni complete, tipo Charles che diventa Adam o Jason che decide che Dakoa beh è più bello…
Secondo me, dipende dal loro mantra dell’indipendenza dura e pura. Questi ragazzi nascono con la libertà incorporata: scelgono cosa mangiare a cena (spesso le mamme mettono tutto sul tavolo e ognuno si serve e mangia un po’ dove capita), decidono come vestirsi già a 4 anni e, a quanto pare, si scelgono pure il nome.
Curioso, poi, che questa libertà identitaria sia racchiusa proprio nel concetto di nomen, parola che in latino deriva da nosco (conoscere). Scegliersi un nome diverso, in fondo, è come affermare: “Questo è ciò che conosco di me stesso e voglio che lo conosciate anche voi.”
Così continuo a chiamarli come mi dicono, cercando di mantenere una certa professionalità. Aspettando sornione il giorno in cui anch’io, quando mi chiameranno Mr.D mi alzerò solenne e dirò… ‘Actually I go by Decimo Meridio Massimo, comandante delle legioni del Nord’
28 novembre
«Mr. D., ma questo pluperfect, come si traduce in inglese?»
«Con il past perfect.»
«Uh?»
«Ma sì, tipo: I had seen, I had won, etc.»
«Ma… è sicuro sicuro… che esiste in inglese?»
«Sicurissimo! E non solo: esiste anche il future perfect.»
«Che sarebbe?»
«I will have seen, I will have won, etc.»
«Ah… ed esiste pure questo?»
«Certo! Perché i verbi servono a descrivere le nostre azioni sulla linea del tempo. E su questa linea… beh, a volte qualcosa succede in un passato più passato di un altro passato, o in un futuro più futuro. Tipo: By the end of the semester, I will have written my essay and impressed my teacher!»
«Sempre troppo spiritoso, Mr. D.»
«Ecco perché studiare il latino è così importante!»
«Perché così potrò dire I had seen e I had won?»
«No, perché è solo attraverso il confronto che impari davvero una lingua! È come con i sistemi operativi: se usi sempre e solo Android, non ne apprezzi davvero i punti di forza finché non lo confronti con iOS, o viceversa. Allo stesso modo, il miglior modo per imparare la grammatica è studiarla confrontando due lingue. Una è il tuo sistema operativo… l’altra è il benchmark.»
«Sì, ma devo proprio confrontarla con un sistema operativo morto?»
28 novembre
Otto cose delle case americane che mi piacciono, che poi neanche so perché mi piacciono, ma so che mi piacciono comunque, e quindi mi piacciono…
1.I portici: quel tocco da film anni ’50, magari con la sedia a dondolo, perfetti per osservare il vicinato o, nei film mentali che mi faccio, per risolvere misteri di CSI. Il luogo ideale per sognare e spiare senza farsi notare.
2.Le decorazioni stagionali fuori casa: una zucca qui, un pupazzo là, un’insegna lì. E ogni casa diventa una pagina Pinterest in tempo reale.
3. Il fatto che hanno due entrate: la porta davanti e quella dietro, come due universi paralleli. Davanti, il front yard impeccabile: prato rasato, fiori curati, tutto in ordine come in una rivista. Dietro, il backyard è il regno della vita vera: barbecue da sgrassare, giocattoli sparsi, magari un angolo più intimo e riservato. È come se ogni casa avesse una doppia anima: il volto pubblico perfetto e quello privato, più autentico e rilassato.
4.Le bandiere: non solo quella americana (onnipresente), ma anche quelle tematiche: “Happy Halloween”, “Welcome Spring”, “Go Ravens!” Ogni casa diventa un messaggio, e ogni stagione ha il suo codice non scritto.
5.I frigoriferi grandi come armadi: un microcosmo con calamite, foto di famiglia, liste della spesa e a volte anche interi sogni congelati. Un pezzo di cuore che si apre ogni volta che hai fame.
6. Il legno che scricchiola: se una casa non scricchiola, non è davvero americana. Il legno racconta storie, accompagna i passi e ci ricorda che quella casa è viva. Ogni scricchiolio è una piccola colonna sonora: qualcuno che sale per controllare i bambini, qualcun altro che scende per uno spuntino notturno. Senza, il silenzio sarebbe perfetto… e la perfezione, diciamolo, mi annoia.
7.Le cassettine per i libri da scambiarsi: piccole librerie fai-da-te in miniatura, di solito piazzate nel front yard di qualcuno. Ogni quartiere ne ha una, piena di tesori inaspettati: dal best-seller di dieci anni fa a manuali di giardinaggio che nessuno leggerà mai. Mi piace l’idea di passare, lasciare un libro che non ti serve più e prenderne un altro, come se il quartiere fosse una grande biblioteca a cielo aperto.
8.I seminterrati giganti: dove c’è di tutto, ma proprio di tutto: sala giochi, palestra, cinema, rifugio anti-zombie… un paradiso per chi ama accumulare oggetti che non servono a niente. 

Tra case che sembrano uscite da un catalogo e vicini che ti augurano “good morning” anche quando la giornata sembra sgangherata come una bicicletta senza catena, il vicinato americano ha un suo fascino perché è un mix di ordine e piccole eccentricità che rende tutto, inspiegabilmente, ’mericano.
29 novembre
Otto cose delle case americane che non mi piacciono, che poi neanche so perché non mi piacciono, ma so che non mi piacciono comunque, e quindi non mi piacciono…
1. La moquette onnipresente
Sembra accogliente e perfetta per camminare scalzi, ma col tempo diventa un diario visivo della tua incompetenza domestica. Una macchia di caffè qui, un po’ di vino là, il pudding giusto al centro, come una firma artistica. Non importa quante volte la pulisci, la moquette assorbe tutto, errori inclusi. Alla fine la chiami “design organico” e speri che gli ospiti non notino il gelato alla fragola fossilizzato nell’angolo dietro al divano.
2. La velocità con cui costruiscono le case
Un giorno c’è un prato vuoto, il giorno dopo una villa pronta per Instagram. Ti viene subito in mente la storia dei tre porcellini: “Basta un soffio di vento e vola tutto?” Poi guardi la tua casa, ancora in piedi, e pensi: “Tutto bene, sì? O l’hanno costruita con la stessa… competenza dei vicini?”
3. Gli elettrodomestici enormi per usi modesti
Nelle cucine americane, tutto è maxi: frigoriferi alti quanto un armadio, forni che potrebbero ospitare una grigliata per un intero condominio e microonde che sembrano pensati per il catering di un matrimonio. Poi li usi per riscaldare la pasta in scatola o il latte per i cereali. E ti ritrovi a pensare a quella pubblicità dei pennelli: “Non ci vuole un elettrodomestico grande, ma un grande elettrodomestico!”
4. I garage-ripostiglio
Alias “la mappa dei Goonies.” Scatoloni pieni di misteri, attrezzi dimenticati, decorazioni natalizie e cose che nemmeno ricordavi di possedere. Ogni volta che ci entro, mi sembra di essere sul set di Ai confini della realtà. Poi mi perdo rovistando e dimentico perché ero sceso. Hey, wait a minute… forse non è una cosa americana, forse è solo mia.
5. Le finestre senza persiane
L’inno americano, The Star-Spangled Banner, celebra “l’alba precoce” (dawn’s early light) come simbolo della resilienza del Paese, il momento in cui, dopo una notte difficile, ci si sveglia e si vede ancora la bandiera sventolare. Ecco, l’alba americana è potente, simbolica… e non perdona. Alle 5 del mattino, la luce entra trionfale dalle finestre senza persiane, invadendo la tua camera come un generale pronto a conquistare il giorno. Patriottico? Forse. Riposante? Per niente.
6. I bagni senza bidet
Un running joke tra salviette, doccette e soluzioni creative. Diventi un vero MacGyver dell’igiene personale.
7. Il comitato del quartiere passivo-aggressivo
Ogni quartiere americano sembra averne uno, e il tuo vicino, che poi è ovviamente il presidente dell’associazione, ne è il perfetto rappresentante. È quello che ti saluta calorosamente ogni volta che ti vede, e poi butta lì mezze frasi al retrogusto di polpetta avvelenata: “Sai, tutti noi nel quartiere appendiamo una ghirlanda natalizia alla porta… quest’anno pensi di unirti alla tradizione, che dici?” “Il tuo prato ha un aspetto così naturale, ricorda un po’ i documentari sulla savana! Che stile selvaggio, lo adoro!”
Ogni commento è confezionato con un sorriso smagliante e una cortesia perfetta, e a me viene sempre voglia di mettere le decorazioni natalizie ad agosto, solo per vedere l’effetto che fa.
8. I vialetti pieni di foglie
Spettacolari, un quadro autunnale da Instagram… fino a quando quelle foglie non iniziano a cadere. E non è che cadono: si suicidano in massa. Tu affronti la situazione con un piccolo rastrello da spiaggia, cercando di riportare ordine nel caos, mentre dall’altro lato della strada il tuo vicino – sempre lui, il presidente del comitato di quartiere – sfodera un marchingegno tipo Ghostbusters: aspira, trita e impacchetta le foglie con un’efficienza che farebbe impallidire un ingegnere NASA. Quando pensi di aver finito, un colpo di vento ti regala un altro tappeto di foglie, e lui, dal suo vialetto perfettamente sgombro, ti sorride e ti dice: “Hai visto il mio supermegagalattico professional blower 3000 che bello? È in saldo da Home Depot (che poi sarebbe il nostro Brico center)!”
Alla fine, queste cose sono come i parenti eccentrici: ti infastidiscono, mettono alla prova la tua pazienza e la tua (in)competenza, ma non puoi farne a meno. E forse, proprio per questo, impari ad amarle.
30 novembre
Quando andavo al liceo, c’era questo professore di filosofia leggendario: cattivissimo, un po’ misantropo. Uno di quei tipi che sembrano usciti da una casa di pietra persa tra i monti, con un caminetto sempre acceso e nessuno con cui parlare. Forse era per questo che era misantropo: troppa intelligenza e poca gente all’altezza. Sembrava il nonno di Heidi, ma da giovane e con una laurea in metafisica.
Guidava una Fiat 500 rossa, vecchissima, scrausa, che pareva tenuta insieme dalla filosofia stessa. Gli studenti più grandi raccontavano che, quando era caduto il muro di Berlino, l’aveva guidata fin su in Germania per prendersi un mattone, che troneggiava nel suo studio come una reliquia sacra. Un souvenir che diceva: Io c’ero. E voi no.
La sua macchina era un’icona vintage, come le sue giacche di velluto a coste marroni: roba che oggi trovi nei negozi hipster a prezzi improponibili, ma che allora lo rendevano più un personaggio che una persona. E io, come tutti, lo ammiravo e lo temevo… anzi, diciamolo, lo temevamo e basta.
Oggi, qui negli USA, capisco che il cerchio della vita non perdona. Guido una Chevy Spark giallo pastello – cambio manuale, perché il masochismo non ha confini – che i miei studenti hanno ribattezzato con affetto la banana car. Insegno una lingua morta, porto sempre una sciarpa (gadget che qui gli uomini usano poco, ma io sfoggio con orgoglio), e sono quel tipo di prof pignolo con i voti che fa sospirare gli studenti, tipo: “Ugh, my ablative wasn’t perfect, but cut me some slack, man—I was close enough, c’mon!”
In pratica, sono diventato come quel prof di filosofia, solo con meno intelligenza e più sciarpe. Dove lui aveva la 500, io ho la banana car. Dove lui aveva le giacche di velluto, io ho le sciarpe fuori stagione. Un personaggio completo: il prof con la macchina gialla, la lingua morta e l’ossessione per i dettagli.