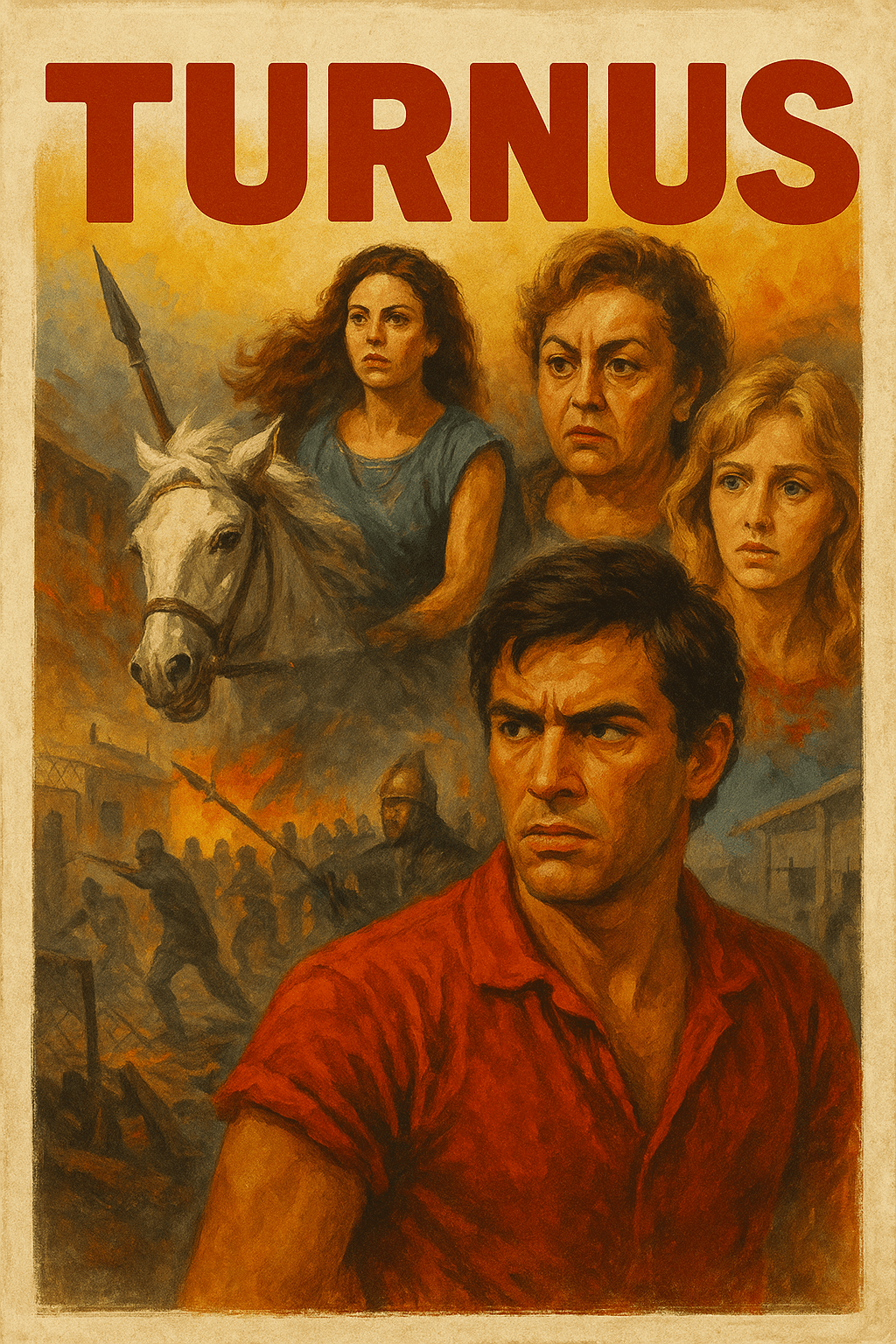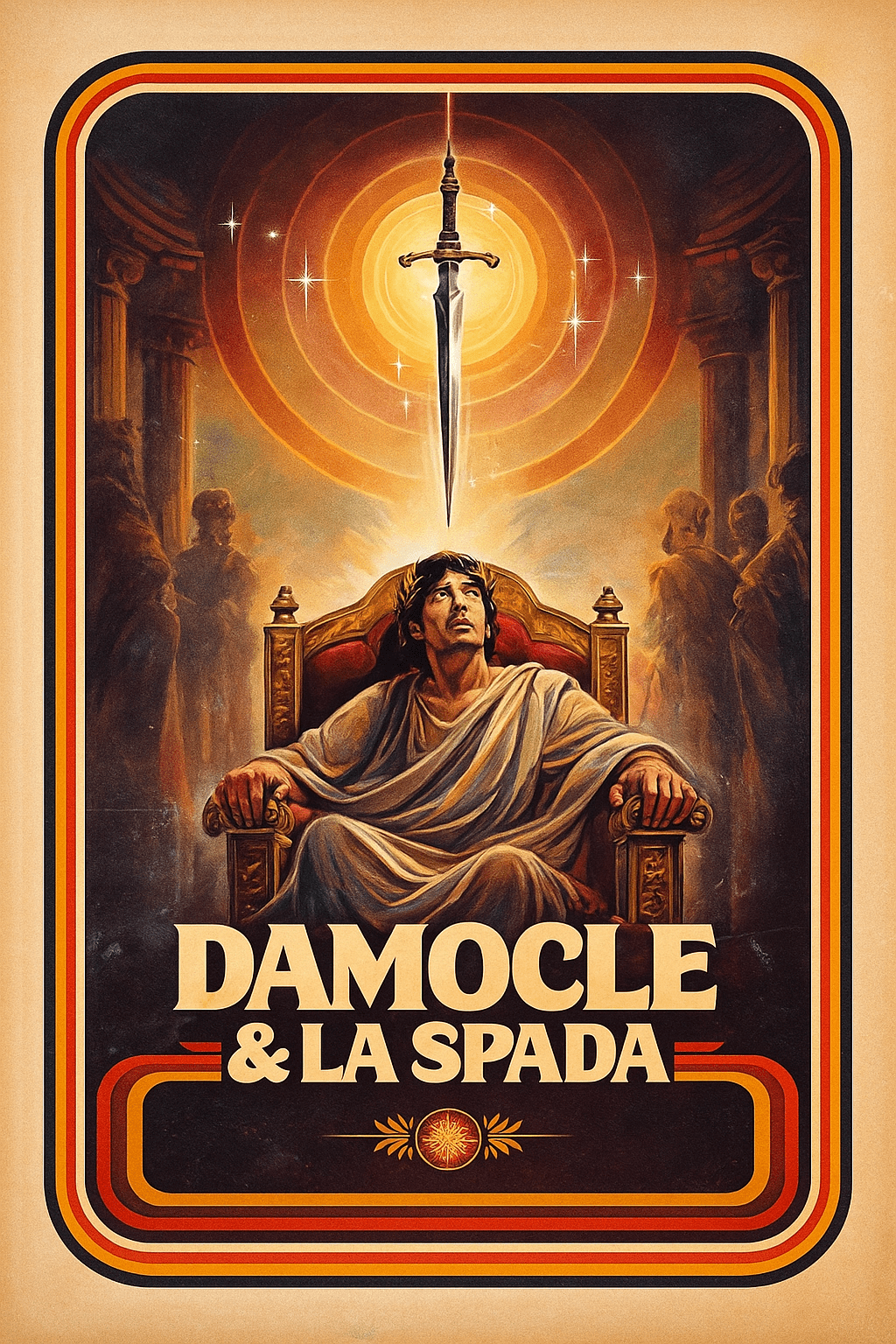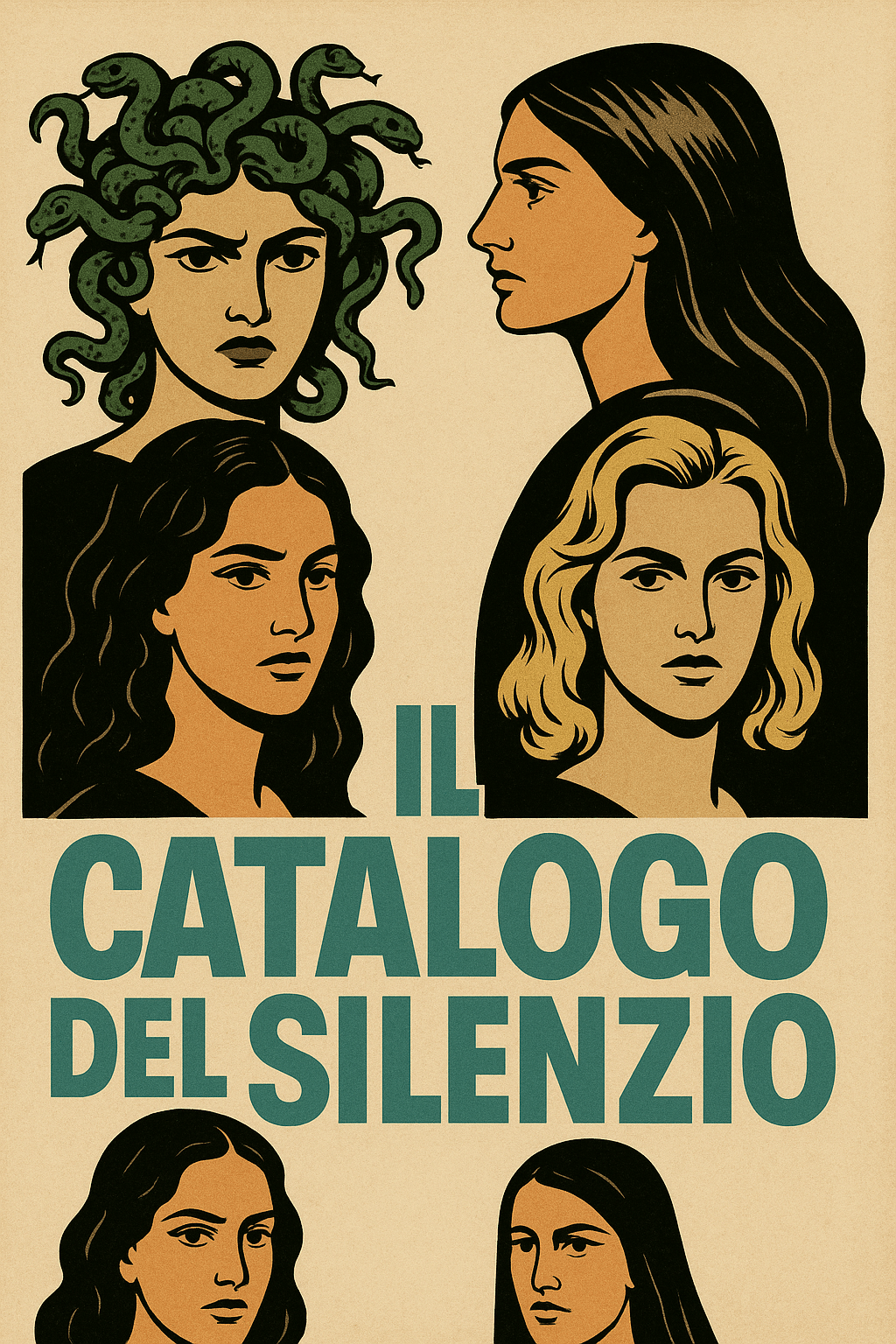Seduti nel diner Nautilus subito a ridosso del raccordo anulare, io e officer Rizzo condividiamo il primo di una lunga serie di caffè della giornata.
Simile a un gigantesco camper ricoperto da pannelli in acciaio inossidabile, l’edificio è stretto e allungato con il tetto bombato e una gigantesca insegna a neon. Un maestoso bancone di servizio domina l’interno, con un’area adibita a cucina contro la parete posteriore e sgabelli a pavimento per i clienti di fronte. Una fila di cabine a ridosso della parete anteriore e alle estremità delimita il perimetro della struttura. L’arredamento con elementi art déco ricorda vagamente l’aspetto dei vagoni ristorante degli intercity.
I diner sono una cosa tutta americana. In italiano non c’è una vera e propria parola per tradurli. Definirli tavole calde è riduttivo e in parte ne toglierebbe il fascino vintage; chiamarli ristoranti è pretestuoso e li eleverebbe a luoghi troppo formali. I diner sono non-luoghi, edifici modesti situati su strade di grande traffico, posti dove a qualsiasi ora del giorno e della notte si può ordinare un pasto caldo o una tazza di caffè; cibo poco elaborato da mangiare da soli in un posto senza pretese.
È molto presto, eppure il locale è già stipato di gente. Dal finestrone alla nostra destra vediamo biancheggiare le prime luci del giorno che illuminano Providence Road; il cielo promette un’altra giornata fredda e soleggiata di fine novembre. C’è un profumo di ‘Merica buona e rassicurante nell’aria, di caffè forte e nero bollente appena uscito, di uova strapazzate, di pane tostato e di bacon che sfrigola nelle padelle. Il Nautilus si trova su una via trafficata che collega il centro città alla contea, lo sterminato sobborgo di casette bifamiliari senza pretese, proprio come il Nautilus.
Poso la tazza sul tavolo di legno sbrecciato: «Pensavo l’avessero chiuso questo diner. Mi ricordavo che ci avevano fatto uno Starbucks. Lo sapevi che quello nell’intersezione tra Providence e Maple Avenue l’hanno chiuso la scorsa settimana? I diner stanno sparendo insieme alle vite semplici e senza pretese».
Officer Rizzo cambia espressione, alza la testa dalla tazza e mi fissa senza parlare.
«Che c’è?» chiedo, anche se so già che piega sta prendendo questa conversazione.
«Adesso me lo dici cos’è successo ieri alla Silvana High? È mezz’ora che siamo qui e continui a parlarmi di diner americani».
Sono stanco, svuotato e confuso, non ho più né la voglia né la forza di tergiversare: «Una cosa brutta…» dico abbassando gli occhi, quasi mortificato.
«Lo so, ma ora devi collaborare e mi devi raccontare tutto, per bene e dall’inizio, perché anche se siamo amici io sono pur sempre un poliziotto…». Rizzo allunga una mano nella tasca dei pantaloni e recupera un’elegante agendina Moleskine nera e una penna. Alla nostra destra l’aurora nascente cosparge la terra di nuova luce: «Non devi aver paura, Mr. D, ti prometto che capirò…»
«Non sei tu quello che deve capire…»
«È per questo che voglio che ne parli. Tenere tutto dentro non aiuta» dice officer Rizzo sforzandosi di sorridere; dovrebbe essere un sorriso rassicurante, ma in realtà assomiglia più a una smorfia.
«È successo tutto durante la seconda ora» sospiro facendomi forza, «avevo… avrei dovuto avere un’ora buca ma dalla segreteria mi hanno chiesto di andare a coprire la classe di Mr. Whittle.»
«Immagino con che spirito ci sei andato…» dice officer Rizzo con uno sguardo complice, come a darmi coraggio.
«Ero seccato, ovvio… mentre camminavo verso la classe di Mr. Whittle, all’altezza del tuo ufficio e quello della guidance ho sentito il colpo secco».
Officer Rizzo scrive impassibile sull’agendina, senza parlare.
«Lì per lì ho pensato che qualcuno avesse fatto cadere qualcosa per terra, tipo una catasta di libri. È successo proprio come avevi detto tu… come se le orecchie avessero decodificato il rumore, ma il cervello si fosse rifiutato di credere che nel mondo potesse esserci così tanto dolore».
Officer Rizzo allunga la mano verso la tazza e beve un sorso di caffè, poi apre la bocca, come per dire qualcosa, ma all’ultimo forse cambia idea e rimane in silenzio.
«Ho visto un paio di persone correre verso il suono, ma io ho tirato dritto, perché non volevo capire, perché ero in ritardo. Quando ho raggiunto la classe di Mr. Whittle, Mr. Cummings, che doveva aver fatto la prima metà di supplenza, ha indicato con l’indice l’orologio al polso, come a farmi presente che ero in ritardo. Io ho scosso la testa e gli ho detto che forse era successo qualcosa lungo il corridoio».
Officer Rizzo si scherma la faccia con la mano. Adesso il sole dalla vetrata è diventato accecante e faccio fatica a distinguere i contorni del suo viso.
«A ogni modo» continuo socchiudendo le palpebre accecate dal sole che inonda la vetrata, «come Mr. Cummings è andato via… dalla segreteria ci hanno detto che eravamo entrati in lock-down. Ho chiuso la porta a chiave sbuffando, pensando che si trattasse della solita esercitazione. Mentre dicevo ai ragazzi di stare in silenzio e di andarsi a sedere come sempre sul pavimento, sotto ai banchi, mi è tornato in mente il rumore nel corridoio, due colpi in sequenza, la gente che correva verso quel trambusto. Stavo rivivendo la scena del corridoio come in un sogno sfuocato, come se gli occhi e la mente si stessero muovendo in differita… Non era il rumore di libri che cadevano, vero?»
«Ho paura di no…» dice Rizzo scrivendo.
«Allora ho cominciato a tremare, non tanto per me… per i ragazzi… Siamo rimasti in quell’aula in silenzio per due ore, tutti zitti e impauriti. Le serrande abbassate, un buio fitto e il rumore incessante dell’impianto di aerazione a tenerci compagnia. Fuori, come da un mondo distante e piccolo sentivamo rumori confusi, di pale di un elicottero, di ambulanze, sirene».
Officer Rizzo scuote la testa, il sole alle sue spalle fa quasi male agli occhi: «Ma chi ha sparato?»
«Non mi ricordo…» mento abbassando la testa cercando di ricacciare indietro le lacrime frammiste a un profondo senso di vergogna e di rabbia.
«Non ti preoccupare» dice officer Rizzo, «è tutto finito…» poi ripone la Moleskine e la penna nella tasca e si alza dalla sedia.
Quando mi dà le spalle per dirigersi verso la porta trovo il coraggio di parlare: «Avevi detto a Kenzie che ci saresti stato… che ci avresti protetto e invece ci hai mentito…» bisbiglio lentamente con un nodo di rabbia che mi stringe la gola, la testa tra le mani e le palpebre chiuse che ormai non riescono più ad arginare le lacrime.
Officer Rizzo tentenna un attimo, poi scompare oltre la porta mentre riemergo a fatica dal mio sogno a occhi aperti, scrollando la testa piena zeppa di pensieri viscidi e appiccicosi come syrup dei pancake, come sangue rappreso. Il diner si dissolve poco alla volta trasformandosi piano piano nel nuovo e funzionale Starbucks per millennials. C’è odore dolciastro ora, di peppermint mocha e di caramello, odore di Natale e di plastica lucida.
Seduto da solo su uno sgabello che si affaccia sulla vetrata a ridosso di Providence Road, guardo i clienti che vengono riflessi come tante ombre sul fondale dell’Acheronte. Davanti a me il vento gelido continua a sferzare la strada deserta, il mio portatile ancora acceso, aperto sulla pagina dell’Herald Sun mi informa che la batteria è quasi scarica. Dal soffitto filtra una luce abbacinante, da sala operatoria, che illumina il mobilio moderno ed essenziale. Pochi clienti seduti sui divanetti osservano le loro vite riflesse dagli schermi dei Macbook, mentre i commessi con le cuffie e gli speaker si prodigano a completare le comande degli automobilisti che dall’esterno prendono mochaccini dal drive-thru. Fuori dalla finestra continua a piovere a dirotto, una pioggia pesante frammista a neve.
La voce di officer Rizzo si dissolve lentamente in testa.
Perché se non ci fosse il male, forse non capiremmo il bene. Perché per ogni cosa brutta che accade ce ne sono dieci belle, perché il futuro ci è stato affidato ma non è stato ancora scritto, ed è bello così.
Abbasso la testa sul portatile rileggendo per la millesima volta lo stesso articolo del giornale, come se ogni volta cercassi una spiegazione diversa senza mai riuscire a trovarla, un po’ come quando si legge una pagina di un libro senza prestare attenzione, con gli occhi che scorrono le lettere mentre la mente è altrove, e quando si arriva in fondo bisogna ricominciare da capo.
Fuori il vento gelido frammisto a pioggia e nevischio continua a frustare Providence Road. Il cielo è più scuro del blackest black, il nero più nero. Non filtra il benché minimo raggio di luce. Alla radio Tom Petty e gli Heartbrackers cantano:
…Into the great wide open
Under them skies of blue
Out in the great wide open
A rebel without a clue…
Ho finito di leggere l’articolo per l’ennesima volta, bevo un altro sorso di peppermint mocha dolce e zuccherato e ricomincio da capo…
Ora, a questa storia sono legato come si è legati ai luoghi dell’anima: quelli che non si dimenticano, anche quando fanno male. In questi giorni ritorna l’anniversario — silenzioso, ostinato — della morte di una persona che, proprio alla vigilia di quella che in America chiamano holiday season, decise di spegnere la propria luce.
Di questa storia parlo anche in Hey, sembra l’America: non perché da lì sia nato il libro, ma perché certe ferite chiedono un tempo tutto loro per essere raccontate, e a volte trovano spazio dove meno te lo aspetti.
Oggi la ripropongo perché mi sembra il gesto più giusto per ricordare chi c’era, chi c’è… e chi continua, a modo suo, a camminare accanto a noi.
Qui un link più serio, che spiega il perché e il percome. https://lapisetlux.blog/2020/06/28/made-me-think-of-you/#like-1523
Photo by Jocelyn Morales on Unsplash