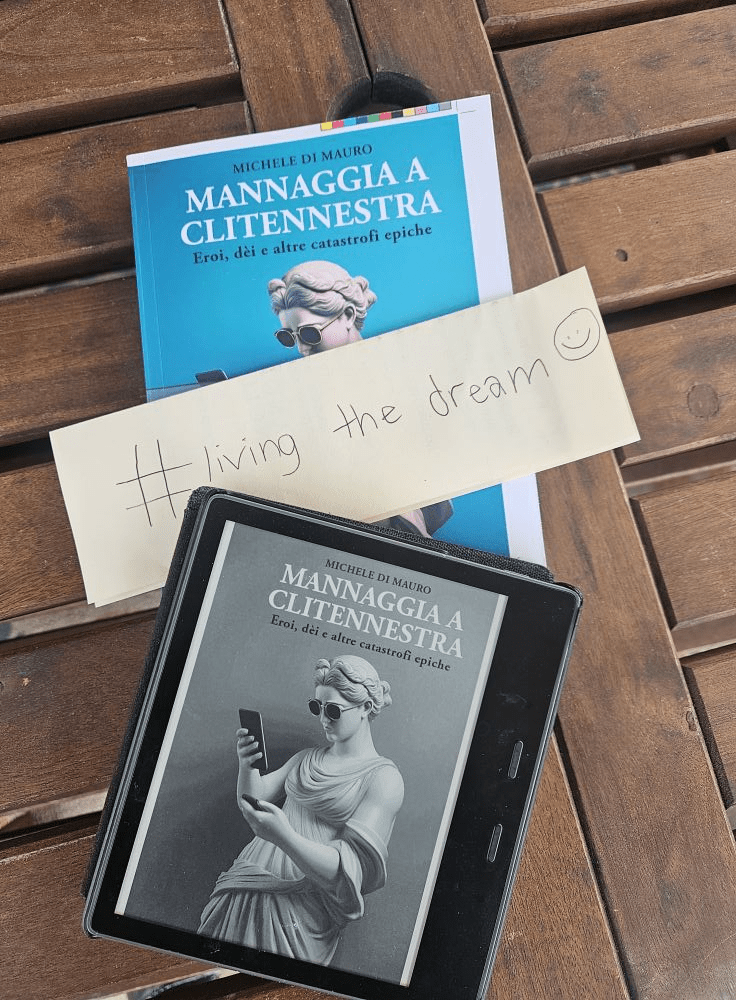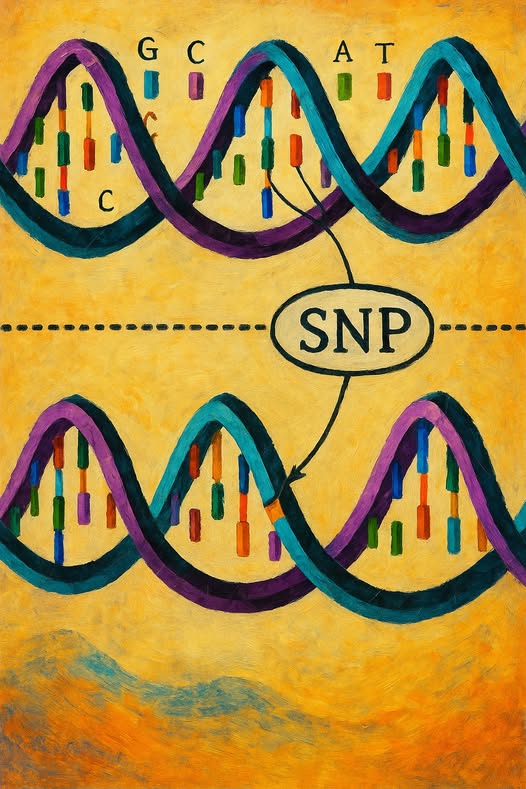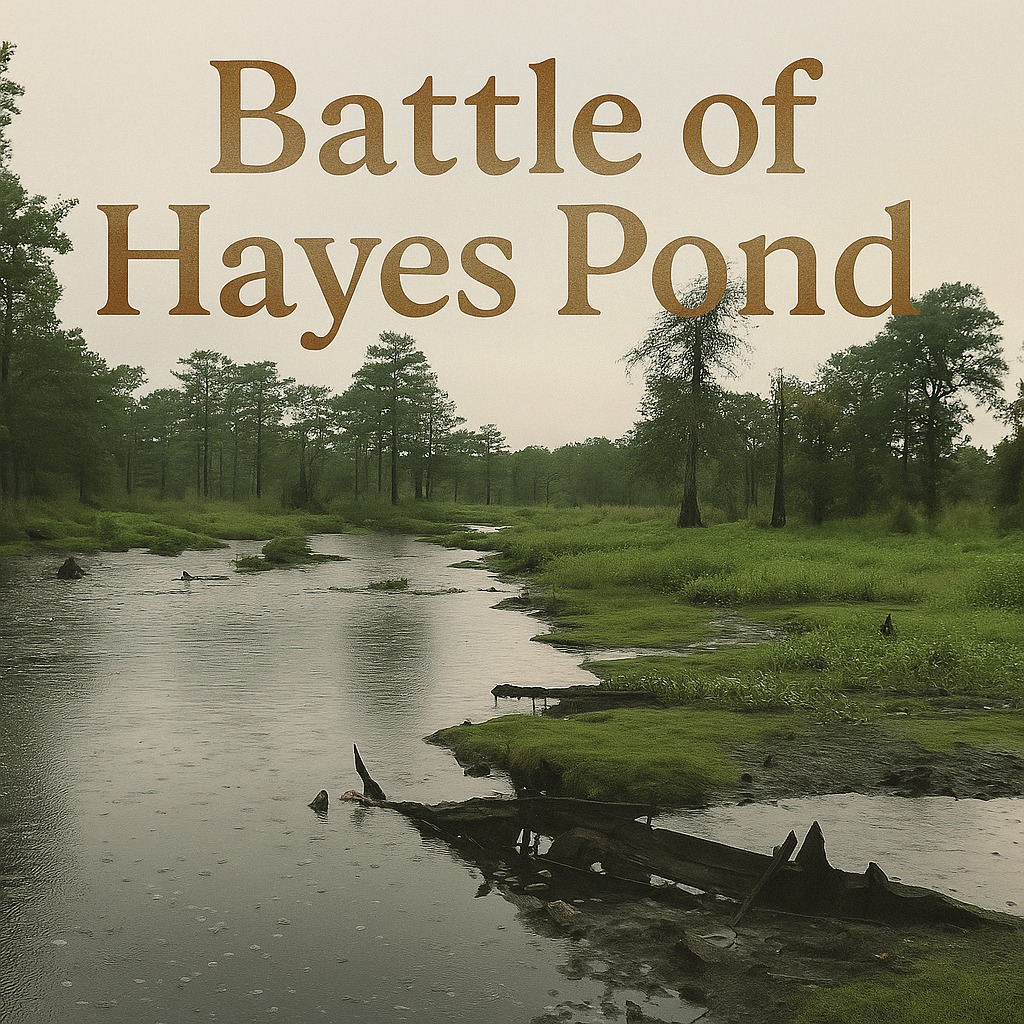A volte, nelle grandi battaglie, vincono gli sfigati.
Gli underdog della storia, insomma.
Quelli che per una sera, un’alba o una riga in fondo a un libro, riescono a spiazzare i giganti.
Come i Tespiesi alle Termopili, rimasti a morire con Leonida anche se nessuno li aveva davvero invitati.
O quei quattro gatti di Pidna, che combatterono fino all’ultimo pur sapendo che la Macedonia era ormai un quiz a risposta multipla per Roma.
Come Milziade a Maratona, che vinse la corsa ma poi inciampò nel processo.
O Cleomene, re spartano, che spaccò l’Argolide con due buone mosse e poi si autodistrusse. Per noia, o per stile. O entrambi.
Perché la storia — quella vera, quella che sa di sangue, fumo e piedi sudati —
non premia sempre chi resta in piedi alla fine,
ma chi riesce, anche solo per un attimo, a far saltare in aria il copione.
Mi spiego?
Mi spiego.
Notte.
Nuvole basse, luna opaca.
La donna nella macchina combatte il gelo sfregandosi le mani. I rumori arrivano ovattati dal vento: colpi secchi, grida, forse ululati.
D’improvviso, intravede Mr. Blake correre lungo il campo, strillando come un coyote ferito.
Subito dietro Catfish Cole, suo marito, che rotola oltre la recinzione e sparisce nel fosso. Senza neanche guardarla.
Solo a quel punto lei si muove.
Mette in moto, ingrana la marcia, parte.
Un urlo disumano squarcia la notte.
Ma la corsa dura poco: un tronco, un sobbalzo, la macchina scivola nel fosso.
Sbatte la testa. Sente un fiotto caldo bagnarle lo zigomo. Chiude gli occhi, mentre alle sue spalle gli indiani ululanti si avvicinano, lanciando grida di guerra…
Era cominciato tutto tre giorni prima, con due croci bruciate nella contea di Robeson, North Carolina, a circa trecentocinquanta miglia da Washington D.C.
La prima davanti alla casa di una donna nativa americana, colpevole di aver intrattenuto una relazione con un uomo bianco.
La seconda davanti a una famiglia Lumbee che si era trasferita in un quartiere “bianco”.
Era il 12 gennaio 1958.
Da decenni, la contea era divisa in tre distretti razziali: tre scuole, tre autobus, tre fontane.
Ma le cose stavano cambiando.
La sentenza Brown v. Board of Education aveva abolito la segregazione scolastica.
E la Carolina del Nord aveva riconosciuto ufficialmente la tribù dei Lumbee — la più numerosa a est del Mississippi.
Il giorno dopo, James William “Catfish” Cole, leader del Ku Klux Klan, annunciò un grande raduno “anti-indiano” a Maxton.
I volantini si diffusero in fretta.
In città, le armerie finirono le scorte.
I membri del Klan giravano insultando, distribuendo volantini, alzando i toni.
I Lumbee, in silenzio, si preparavano. Senza far rumore.
Alle sette di sera, i primi klansmen arrivarono nel campo.
Tuniche bianche sotto i giacconi, una croce da bruciare, un telone con tre K rosso sangue.
Un camion trasformato in palco. In sottofondo, l’inno evangelico: Kneel at the Cross.
Catfish Cole si aspettava cinquecento persone.
Alle diciannove, ce n’erano sì e no una cinquantina: pochi ma rumorosi, con braccia alzate e i piedi congelati.
A quanto pare, le ideologie erano rimaste al calduccio.
Il freddo, più convincente di mille comizi, aveva già fatto strage tra le file del fanatismo.
Nel frattempo, al limitare del campo, i Lumbee erano diventati quattrocento.
E quei volantini, letti attentamente, avevano fatto il resto.
Pubblicità al contrario.
Il Klan aveva chiamato a raccolta — e aveva radunato i suoi oppositori.
Così, alle otto e un quarto, mentre sotto la croce si raccoglievano a malapena una cinquantina di klansmen, dall’altra parte del campo quattrocento nativi si stavano muovendo.
Decisi. Compatti. In silenzio.
Ignorando l’avvertimento dello sceriffo, Catfish Cole e i suoi continuarono a cantare e incendiare croci.
Finché i Lumbee non partirono alla carica.
A quel punto, i membri della setta si sbandarono come figuranti in fuga da un film girato male.
Cole, nella confusione, si dimenticò pure la moglie, che lo aspettava in macchina a bordo strada.
Così, per una sera, a riscrivere la storia furono loro: gli ultimi, gli sfigati, i non previsti.
Gli underdog insomma.
Quelli che entrano in scena senza copione
e riescono, per un istante,
a cambiare il finale.
La donna riprende conoscenza. Fiotti caldi di sangue le bagnano le guance.
Gli indiani la raggiungono, entrano nel fosso, spingono la macchina, la riportano sulla carreggiata.
Un Lumbee apre lo sportello.
La donna trema, piange, implora pietà, grida alla luna opaca il nome di Catfish Cole.
L’uomo la fissa in silenzio, poi si toglie la giacca, strappa a fatica un lembo della manica e lo stringe con forza attorno alla ferita, fermandole il sangue.
Le nuvole si diradano.
Riemerge un quarto di luna scintillante.
Al di là della pianura, i Lumbee danzano.
Sparano colpi in aria, ridono, gridano.
Celebrano la vittoria della Battle of Hayes Pond.
Una di quelle notti in cui vincono gli sfigati.
E la storia, per una volta, si concede un colpo di scena.